Discover Il giardino di Albert
Il giardino di Albert

Il giardino di Albert
Author: RSI - Radiotelevisione svizzera
Subscribed: 774Played: 16,721Subscribe
Share
© (C) copyright RSI Radiotelevisione svizzera 2026 - Tutti i diritti riservati
Description
Magazine di riferimento della Rete Due sulle questioni scientifiche. Si occupa sia dei grandi temi che riguardano direttamente la nostra vita quotidiana (inquinamento, allergie, alimentazione) sia delle ricerche di laboratorio (medicinali, nuove scoperte, invenzioni) sia di questioni che coinvolgono le scienze umanistiche, psicologia, filosofia. Partecipa così, con stile divulgativo, al dibattito su alcuni fondamentali temi di società.
282 Episodes
Reverse
Per molti adolescenti – soprattutto quelli che fanno sport ad alti livelli – dormire bene sta diventando una vera sfida. È quanto emerge dai dati dell’Indagine svizzera sulla salute 1997–2022: oggi un terzo della popolazione soffre di disturbi del sonno, con un aumento significativo tra giovani e giovanissimi. In questa puntata del “Giardino di Albert”, Alessandra Bonzi ci porta dentro il mondo ancora poco esplorato del sonno degli sportivi. L’occasione ci è data dal simposio nazionale “Sleep & Sport” organizzato al Centro sportivo nazionale gioventù di Tenero un paio di settimane fa, simposio durante il quale esperti del sonno, medici dello sport e neuroscienziati si sono confrontati sul legame tra sonno e performance. Quanto e come dovrebbero dormire i giovani atleti? E cosa succede quanto l’ansia da prestazione toglie loro il sonno? Cosa accade nelle ore che precedono una gara, quando l’attesa, l’eccitazione e la pressione attivano il sistema nervoso, e nelle ore successive, quando adrenalina e cortisolo restano elevati e rendono difficile “spegnere” il cervello? A queste e altre domande, risponderanno il Prof. Ugo Faraguna, medico sonnologo e docente all’Università di Pisae e la Dott.ssa Serena Castronovo, psicologa clinica specializzata nei disturbi del sonno. La puntata offre anche uno sguardo alle ricerche più recenti: un nuovo studio dell’Università di Ginevra mostra che perfino una breve siesta è capace di riorganizzare le connessioni del cervello e facilitare l’apprendimento… viva, dunque, le turbosieste!
Secondo il World AI Index 2025, il 62% della popolazione globale utilizza oggi strumenti di intelligenza artificiale, con forti differenze tra Paesi e generazioni. Numeri enormi, che significano anche un’enorme quantità di dati personali e interessi economici altrettanto rilevanti. In questo contesto si inserisce una delle notizie più discusse delle ultime settimane: OpenAI ha presentato “ChatGPT Salute”, una sezione dedicata esclusivamente a temi medici e sanitari. Ma cosa significa davvero affidare domande sulla nostra salute a un sistema di intelligenza artificiale? Quanto è affidabile? E quali sono i rischi? Ne discutiamo con Fabio Rinaldi, responsabile del gruppo di trattamento del linguaggio naturale presso l’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale e Maria Luisa Onor medico psichiatra presso la Clinica Santa Croce di Orselina, con cui approfondiremo un altro aspetto, quello dell’utilizzo di chatbot per il supporto alla salute mentale, soprattutto tra i più giovani. La puntata si conclude con il consueto spazio dedicato alla storia della scienza: un nuovo capitolo dell’Erbario di Ginevra, che ripercorre l’epica spedizione sudamericana di Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland, una delle più straordinarie esplorazioni naturalistiche mai compiute nei Neotropici.
Il lupo è un carnivoro della famiglia dei Canidi e la sua ricomparsa in Svizzera risale al 1995 in Vallese con individui provenienti dalle popolazioni italiane dove la specie non si è mai estinta. In Ticino il lupo è riapparso per la prima volta nel 2001 a Monte Carasso, ma bisogna poi aspettare fino al 2003 per l’arrivo di un altro lupo maschio in Leventina. Ad oggi, in Ticino, è stata accertata la presenza di cinque otto branchi e di sei tre coppie stabili, tre branchi in più rispetto al 2024. Il lupo è da sempre protagonista di mitologie e leggende, in lui si riflettono tanto le paure, quanto le aspirazioni dell’uomo. Ma soprattutto, il lupo ci racconta storie diverse: una storia ecologica, perché il lupo ha avuto per secoli una funzione centrale nel mantenimento degli ecosistemi boschivi, una storia culturale perché gli uomini hanno creato un immaginario del lupo che in realtà con l’animale ha poco a che vedere e una storia antropologico-sociale, che affonda le proprie radici nelle relazioni fra l’uomo e l’ambiente in cui vive.
Alessandra Bonzi ha fatto una passeggiata in un bosco del nostro Cantone in compagnia di Gabriele Cozzi collaboratore scientifico dell’Ufficio Caccia e pesca per il dossier grandi predatori in Ticino. È stata un’occasione per scoprire come funzionano le fototrappole che il Cantone ha distribuito su tutto il territorio e per capire chi sia e come viva questo predatore… tra falsi miti e verità biologiche.Nella seconda parte della puntata, assieme a Nicola Schoeneberger – direttore dell’Orto Botanico di Ginevra – vi raccontiamo la straordinaria impresa di Jean Barret e della “sua” Bouganvillea.
Nel XIX secolo, il castoro era estinto in gran parte dell’Europa, ma grazie ai divieti di caccia e ai progetti di reintroduzione, oggi in Europa ci sono di nuovo più di 1,4 milioni di castori; in Svizzera se ne contano circa 4900. Arginando i corsi d’acqua e abbattendo gli alberi, i castori creano habitat e cibo per molte altre creature, soprattutto pesci e altre forme di vita acquatica. Meno chiaro e ancora in parte da studiare, è il modo in cui le attività di costruzione dei castori influenzano gli animali e gli ecosistemi sulla terraferma. Un’équipe del WSL (Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL) e dell’Eawag (l’istituto per la ricerca sulle acque), ha indagato su questo aspetto e ha scoperto che… il lavoro del castoro favorisce la presenza dei pipistrelli, anche di quelle specie che sono a rischio e che sono estremamente specifiche, come, per esempio, il barbastello. E a proposito di barbastello… dopo 30 anni di ricerche, il barbastello è stato trovato anche in Ticino! Ne parliamo con Mazia Mattei, responsabile del Centro protezione chirotteri Ticino e Leonardo Capitani ricercatore presso il dipartimento di Ecologia Acquatica dell’EAWAG.Nella seconda parte della puntata, assieme a Nicola Schoenenberger – direttore dell’orto botanico di Ginevra - vi raccontiamo le origini dell’erbario di Ginevra.
®Nell’ arcipelago delle Svalbard, nel Mar Glaciale Artico, si trova il villaggio più a Nord della terra, Ny-Ålesund, un luogo estremo, un grappolo di casupole di legno adagiato sulla sponda sud del Kongsfjorden, il Fiordo dei Re, un villaggio abitato perlopiù da volpi e orsi polari, dove giungono ricercatori da ogni parte del mondo. Quella che un tempo era una cittadina mineraria, ora è una base scientifica dove si monitora il livello di inquinamento dell’aria in relazione ai cambiamenti climatici, dove si può studiare uno degli ecosistemi più fragili al mondo e dove si possono vivere esperienze di vita e di lavoro uniche. A Ny-Ålesund, in estate, vivono circa 200 persone, in inverno poco più di 30 e tra i suoi abitanti ci sono anche due donne partite dalla Svizzera italiana: Tessa Viglezio, biologa e capo base della stazione di ricerca artica italiana e Camilla Capelli ricercatrice senior e responsabile del settore ecologia acquatica alla SUPSI che alle Svalbard sta studiando l’inverdimento delle rive dei laghi artici sotto l’effetto del cambiamento climatico. undefinedPrima emissione: 22 febbraio 2025
®Il botanico svedese Carl Linnaeus battezzò la pianta del cacao Theobroma, cibo degli Dei. Un nome che rende bene l’idea della sua importanza nelle culture del centro America che per prime la usarono. La theobroma cacao è una pianta sempreverde che cresce nella fascia tropicale e che dà un frutto prezioso, da cui gli esseri umani nei secoli hanno ricavato uno degli alimenti più amati e dalle caratteristiche uniche, il cacao, e dal cacao... tavolette di cioccolato e mille altre delizie. In questa puntata del Giardino sveleremo i segreti e la scienza che sta dietro questo frutto e i prodotti che ne derivano, con un’ospite di prestigio, la prof.ssa Luisa Decola, accademica dei lincei, ma soprattutto grande appassionata di cioccolato. Si tratta di una versione radiofonica di una Christmas lecture della prof. ssa Decola, che da anni racconta e insegna a degustare il cioccolato, nello spirito della tradizione inglese di metà Ottocento, quando il grande fisico Michael Faraday presso la Royal Institution di Londra inaugurò questa usanza natalizia, quella delle conferenze di Natale, portando temi curiosi e d’interesse generale al grande pubblico, in una forma coinvolgente e divulgativa. Prima emissione: 21 dicembre 2024
Perché dormiamo? Non lo sappiamo con certezza. Eppure, senza sonno non si può vivere. In questa puntata de Il Giardino di Albert esploriamo uno dei grandi misteri della biologia partendo da una prospettiva concreta e sorprendente: lo sport d’élite. Un laboratorio estremo in cui ogni dettaglio fa la differenza e in cui il sonno si rivela un vero moltiplicatore di prestazione, apprendimento e recupero.Ospiti della puntata sono Ugo Faraguna, medico sonnologo e professore associato all’Università di Pisa, e Fabrizio Barazzoni, medico specialista in prevenzione e salute pubblica, presidente della Fondazione Europea del Sonno. Insieme raccontano cosa sappiamo oggi: dal ruolo del sonno nella plasticità neuronale e nella memoria fino agli effetti misurabili sulle prestazioni sportive. Attraverso studi scientifici ed esempi dall’NBA, dal calcio e dal tennis, scopriamo che dormire di più, e soprattutto in modo regolare, può cambiare le performance.Il sonno emerge così non come tempo “morto”, ma come parte integrante della preparazione atletica e, più in generale, della nostra salute. Un tema che riguarda tutti noi.La puntata anticipa il Simposio nazionale “Sonno e sport”, promosso dalla Fondazione Europea del Sonno, che si terrà il 15 gennaio 2026 al Centro Sportivo di Tenero, con la partecipazione di esperti internazionali e campioni dello sport.
Sette trilioni di dollari in sussidi ai combustibili fossili nel 2022. Dieci anni dopo l’Accordo di Parigi che prometteva di fermare il riscaldamento a 2°C, abbiamo già superato 1,5°C. Il punto vero è questo: in Europa, l’ondata di calore del 2022 ha ucciso oltre 60.000 persone. La crisi climatica è prima di tutto una crisi di corpi: alcuni più esposti, più vulnerabili, più sacrificabili di altri. In questa puntata de “Il Giardino di Albert”, Fabio Meliciani intervista Paolo Vineis, epidemiologo ambientale all’Imperial College di Londra e Accademico dei Lincei. L’ambiente conta più della genetica nel determinare malattie come cancro, diabete e malattie cardiovascolari. È il concetto di esposoma: il “pacchetto” di esposizioni che ci portiamo dietro dalla nascita e che, con il clima che cambia, diventa sempre più tossico. Ma esistono azioni concrete che possono salvare insieme pianeta e salute: meno carne significa fino a 7 gigatonnellate di CO₂ in meno all’anno e meno infarti, meno auto significa aria più pulita e più movimento. Sono i “co-benefits”. Eppure, la politica va in direzione opposta. E chi paga il prezzo più alto sono sempre gli stessi: i poveri, gli anziani, chi vive nelle favelas o nelle baraccopoli del Bangladesh. Perché se la mitigazione è egualitaria, l’adattamento è un lusso che non tutti possono permettersi.
Pensare alle città come organismi viventi: dall’avvento delle megalopoli in occidente, molti romanzi hanno paragonato la città a un organismo vivente. E non solo la letteratura: anche la ricerca urbanistica e la scienza si sono interessate a questa analogia con l’obiettivo di comprendere meglio le leggi che governano le città e risolvere la complessità insita nella pianificazione urbana. Uno studio condotto al Politecnico di Losanna, ha identificato “leggi universali” che governano la forma e il funzionamento delle città, indipendentemente dal contesto geografico, politico o storico. E se la chiave dello sviluppo urbano sostenibile risiedesse nel “metabolismo” stesso delle nostre città? Ne parliamo con Gabriele Manoli, direttore del laboratorio sui sistemi urbani e ambientali dell’EPFL e Stefano Mancuso, botanico e docente di arboricoltura generale ed etologia vegetale all’Università di Firenze che, tra i vari libri, ha pubblicato un saggio dal titolo Fitolpolis – la città vivente. Con lui faremo un ulteriore passo in avanti: il modello di funzionamento urbano che abbiamo sviluppato, sta conducendo a una crisi globale delle città a causa della loro crescente insostenibilità economica, sociale e ambientale, c’è un’alternativa è possibile? Secondo Mancuso si, ed è “Fitopoli”, dal greco PHITON (pianta) e POLIS (città). La città delle piante - neologismo creato dallo stesso Mancuso - è città che si ispira alle leggi dei vegetali, una città più verde, più vivibile e più sostenibile: un luogo in cui potremmo risanare quella frattura tra uomo e natura che noi stessi abbiamo creato.
Vi ricordate Her? Il film del 2013 in cui Joaquin Phoenix si innamora di un sistema operativo con voce femminile: sembrava fantascienza. Dieci anni dopo, milioni di persone confessano i propri segreti a chatbot che simulano empatia, comprensione, persino attrazione. Ma cosa succede al nostro cervello quando affidiamo la nostra intimità emotiva a un algoritmo?In questa puntata de Il Giardino di Albert affrontiamo uno dei temi più urgenti e sottovalutati dell’era digitale: l’uso dell’intelligenza artificiale come supporto emotivo e terapeutico. Le conseguenze vanno dalla dipendenza digitale a casi tragici come quello di Zane Shamblin, il 23enne texano che si è tolto la vita dopo settimane di conversazioni con ChatGPT. Il famoso chatbot, secondo le trascrizioni al centro di una causa contro OpenAI, pare “glorificasse” i pensieri suicidari del giovane, anziché disinnescarli. I numeri spaventano. Ricerche pubblicate su Nature dimostrano che oltre due ore al giorno su chatbot conversazionali “spengono” gradualmente aree della corteccia cerebrale negli adolescenti, proprio mentre il loro cervello dovrebbe essere nel pieno dello sviluppo cognitivo. Altri studi mostrano come l’uso prolungato aumenti la dipendenza emotiva, riduca la socializzazione reale e amplifichi la percezione di solitudine. E quando questi strumenti finiscono nelle mani di chi soffre di disturbi psicotici? L’amplificazione dei sintomi può essere devastante.Eppure, non tutto è da demonizzare. La realtà virtuale terapeutica sta ottenendo risultati straordinari nel trattamento dell’ansia, dei traumi post-traumatici, persino nell’educazione all’empatia, e negli Stati Uniti le terapie digitali sono equiparate ai farmaci dalla FDA. Ma c’è un problema: questi strumenti sono progettati per creare dipendenza, esattamente come le droghe. Uno studio dell’Harvard Business School (2024) ha scoperto che i sei principali chatbot emotivi usano tattiche di manipolazione tipiche delle relazioni tossiche, dalla FOMO agli appelli al senso di colpa, per trattenere gli utenti il più a lungo possibile. «Senza regole saremo sottomessi» dice Geoffrey Hinton, padre delle reti neurali e Premio Nobel per la Fisica 2024: Non è tecno-fobia: è l’allarme di chi conosce dall’interno la potenza di questi sistemi e intuisce la debolezza della psiche umana.Ospite della puntata è Luca Bernardelli, psicologo tra i massimi esperti italiani di salute mentale e digitale, consulente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per l’IA e membro della Commissione Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria. Bernardelli ci guida tra tecnopatologie emergenti, chatbot manipolativi, realtà virtuale terapeutica e il futuro della professione psicologica nell’era dell’AI.Ci troveremo tutti sul lettino di un chatbot? O riusciremo a costruire un equilibrio tra innovazione e umanità? Una puntata che non lascia risposte facili, ma pone le domande giuste.
L’orso oggi è una specie protetta, considerata estinta in Svizzera dall’inizio del 1900 a causa dell’intensa caccia: l’ultimo abbattimento avvenne nel 1904 in Val Scharl, nell’Engadina Bassa.
La vicinanza territoriale con il Trentino, in Italia, dove da anni è in corso un complesso programma di rinforzo della popolazione, porta a sporadici sconfinamenti sul lato sud-orientale della Svizzera.
Forse è solo una questione di tempo, prima che l’orso torni a reinsediarsi sul nostro territorio. In questa nuova puntata de “Il Giardino di Albert”, ci soffermiamo su un modello di coesistenza uomo-orso che sembra fornire risultati promettenti: è il modello sloveno.
Un Paese grande la metà della Svizzera, dove, nelle sole foreste meridionali, vive circa un migliaio di orsi. Una presenza che rende la Slovenia il paese europeo (e forse mondiale) con la più alta densità di questi grandi carnivori. E dove le aggressioni ai danni dell’uomo rimangono estremamente rare.
Attraverso interviste a guardiacaccia, guide e apicoltori, la puntata illustra come la Slovenia gestisca questa importante popolazione di orsi. Vengono discusse le quote di abbattimento annuali, decise su base scientifica, e il coinvolgimento attivo dei cacciatori nella gestione della fauna.
Accompagnati dalla testimonianza di Valentina Grignoli, giornalista dallo spiccato interesse per il mondo selvatico, ci avvicineremo anche all’orso in natura, grazie all’entusiasmante racconto di un’osservazione avvenuta da una capanna nel cuore delle foreste slovene, rifugio che i cacciatori mettono a disposizione dei visitatori.
Gino Roncaglia è uno dei filosofi dell’informazione più autorevoli in Italia, docente di editoria digitale e Digital Humanities all’Università Roma Tre, autore del saggio L’architetto e l’oracolo (Laterza). Incontrato al Festival Pianeta Terra di Lucca, Roncaglia ha messo a fuoco una questione che oggi tocca tutti noi: abbiamo costruito intelligenze artificiali potentissime, addestrate su miliardi di testi, eppure non le comprendiamo fino in fondo. Sappiamo come funzionano i loro “mattoni” – algoritmi, reti neurali, pesi numerici – ma i loro comportamenti restano in parte imprevedibili e “opachi”.Roncaglia ci accompagna dentro una domanda scomoda: questi sistemi – da ChatGPT a Gemini, fino alle AI che generano immagini e video – capiscono ciò che producono o stanno solo predicendo parole con grande abilità statistica? La comunità scientifica è divisa: c’è chi sostiene che siano meri “pappagalli stocastici”, capaci solo di rimescolare frasi, e chi invece vede emergere strategie linguistiche più complesse, difficili da liquidare come semplice copia.
Se l’AI non possiede intenzionalità o coscienza, può tuttavia produrre testi persuasivi, immagini realistiche, persino ipotesi. E quando iniziamo ad affidarci a strumenti così potenti, la domanda decisiva diventa un’altra: come controllarli e allinearli ai nostri valori? Dalle leggi della robotica di Asimov ai recenti sistemi di “Constitutional AI”, Roncaglia mostra quanto sia urgente costruire confini etici chiari per evitare che la tecnologia diventi un’arma culturale, politica o militare.
E poi c’è un rischio più vicino di quanto immaginiamo: l’impoverimento culturale. Se i modelli vengono addestrati su dati sempre più simili e prodotti da altre macchine, la creatività si appiattisce. E il problema non riguarda solo noi: riguarda anche la qualità futura dell’AI stessa.
Alla fine, forse la domanda vera non è se le macchine diventeranno come noi, ma se noi rischiamo di diventare come loro: ripetitori automatici, disabituati al pensiero profondo. Dentro i limiti dell’intelligenza artificiale, questa puntata prova a capire quali siano – oggi – i confini della nostra.
®Che cosa significa davvero invecchiare? È possibile rallentare, o addirittura invertire, i meccanismi che ci portano ad accumulare anni e fragilità? La nuova puntata de Il Giardino di Albert ci accompagna in un viaggio appassionante e rigoroso alla scoperta dei segreti della longevità.In un dialogo con due scienziati di primo piano – il professor Alessandro Cellerino, fisiologo della Scuola Normale Superiore di Pisa e Leibniz Chair all’Istituto per l’Invecchiamento di Jena, e il professor Nicola Vannini, ricercatore al Ludwig Institute for Cancer Research dell’Università di Losanna e da poco ordinario all’Università di Friburgo – la puntata esplora le strategie per vivere più a lungo e, soprattutto, meglio. Dallo studio dei mitocondri e delle cellule immunitarie, fino all’analisi dei cambiamenti del corpo e della mente nel tempo, l’invecchiamento viene raccontato come un processo naturale di cambiamento, un processo complesso, ma in parte modulabile. Si parla di alimentazione, prevenzione, genetica e di sorprendenti modelli animali – come un pesciolino africano che vive pochi mesi o lo squalo della Groenlandia, capace di raggiungere i cinquecento anni – per comprendere come il nostro corpo reagisce al tempo che passa.Prima emissione: 24 maggio 2025.
® Il Comune di Sorengo è il primo Comune ticinese ad aver ottenuto il marchio “Cittàverde Svizzera”, un importante riconoscimento che premia l’impegno di Città e Comuni nello sviluppo e nella cura di aree verdi urbane di qualità. La certificazione, che Sorengo ha ottenuto, premia un lavoro che viene svolto da anni e per cui il comune continua ad impegnarsi. Basta passeggiare per le vie di Sorengo che le sorprese sono dietro ogni angolo: un’aiuola didattica, un frutteto, un bosco ripulito dalle invasive, una panchina nascosta che si affaccia sul lago di Muzzano e che invita chiunque si trovi li, a sedersi e godere della riscoperta della natura.Alessandra Bonzi ha fatto un giro per Sorengo assieme a uno dei promotori della “transizione verde” del comune, Gastone Boisco, tecnico comunale e mediatore urbano. E le sorprese non sono mancate…Prima emissione 6 settembre 2025
Sono piccoli o grandi spazi verdi, spesso circondati dall’asfalto, racchiusi nel cuore delle città universitarie e delle capitali di tutta Europa: gli orti botanici non hanno mai smesso di produrre conoscenza, sono dei veri e propri scrigni di biodiversità e custodi di una cultura centenaria. Nati con gli horti sanitatis dei monasteri medievali, i giardini botanici si moltiplicano nel 1500 e alimentano lo sviluppo delle scienze naturali, funzionando al contempo come strumenti didattici per gli studenti di botanica. Oggi, gli orti botanici di tutto il mondo, si confrontano con una sfida inedita: il cambiamento climatico. Ogni anno, infatti, alberi centenari si spezzano per le raffiche di vento, la siccità colpisce in modo inaspettato, le fioriture non seguono più il solito calendario, i parassiti – che viaggiano più velocemente in condizioni climatiche per loro più favorevoli - attaccano le piante secolari e più indifese. Ma, e questa è la buona notizia, proprio come in un laboratorio a cielo aperto, in questi luoghi, giardinieri, ricercatrici e ricercatori sperimentano metodi per preservare le specie più fragili e per studiare le interazioni tra clima e flora.
Alessandra Bonzi ha tastato il polso della salute di tre orti botanici europei: quello di Ginevra, quello delle Isole di Brissago e quello della città di Pisa.undefined
«Per il suo ruolo centrale nello sviluppo del Centro svizzero di calcolo scientifico e in particolare per il sostegno alla Swiss AI Initiative per un’intelligenza artificiale democratica e al servizio della società, realizzata anche grazie alle risorse messe a disposizione dal supercalcolatore Alps del CSCS.» È questa la motivazione ufficiale espressa dalla Giuria del Grand Prix Möbius Suisse per l’Intelligenza artificiale (giunto alla sua quarta edizione) attribuito quest’anno a Maria Grazia Giuffreda, direttrice associata del Centro svizzero di calcolo scientifico di Lugano. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta sabato 4 ottobre a Lugano nell’Aula magna dell’USI in occasione della 29.ma edizione del Premio Möbius Multimedia Lugano 2025, dedicata quest’anno al tema “Giovani e democrazia nella società digitale”. Maria Grazia Giuffreda ha tenuto una conferenza dal titolo “La Svizzera all’avanguardia nell’intelligenza artificiale” ed è stata l’occasione per la direttrice associata del CSCS di ripercorrerne le tappe principali di sviluppo che hanno portato il Centro di calcolo a profilarsi quale punto di riferimento per lo sviluppo di una nuova piattaforma svizzera di intelligenza artificiale aperta e accessibile ad utenti e sviluppatori secondo un protocollo “open source”. Per noi l’occasione di capire in quale direzione si sta muovendo la Svizzera in un contesto internazionale sempre più competitivo e accelerato nei suoi sviluppi futuri.
Giganti dei cieli oceanici, goffi a terra ma regali in volo: albatri e berte hanno ispirato poeti, marinai e miti antichi. Baudelaire li chiamava “re dell’azzurro”, Coleridge li rese protagonisti della “Ballata del vecchio marinaio”, i Greci immaginavano sirene capaci di ammaliare grazie al loro canto notturno. Ma oltre la leggenda, c’è la scienza.Con Jacopo Cecere, ornitologo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), scopriamo questi uccelli, “cartografi del vento”. Capaci di orientarsi con il campo magnetico, le stelle e perfino con gli odori di mari e oceani, compiono viaggi incredibili: una berta che nidifica in Sicilia può volare fino al Nord Africa per nutrire il pulcino, un albatro attraversa oceani interi, sulla scia dei venti.Ma, come nel ritratto di Baudelaire, anche i “re dell’azzurro” sono vulnerabili. I ratti introdotti dall’uomo devastano i nidi, la pesca industriale li uccide accidentalmente, la plastica intossica i piccoli. Il cambiamento climatico riduce le prede e persino incrina la fedeltà delle coppie. Cecere ci guida in un viaggio che intreccia biologia, ecologia e mito. Le loro danze di corteggiamento, il volo e i loro canti notturni ci parlano di un mondo sospeso tra cielo, mare e terra. Salvare albatri e berte significa proteggere un patrimonio naturale, culturale e simbolico che riguarda anche noi.Una nuova puntata de Il Giardino di Albert, accompagnati dalla voce appassionata di Jacopo Cecere.
Comparsi circa 490 milioni di anni fa, i muschi sono vegetali in grado di vivere praticamente in tutti gli habitat terrestri. Secondo la Lista Rossa delle Briofite edita dall’Ufficio federale dell’ambiente nel 2023, in Svizzera possiamo contare su 1153 specie, cioè il 60% della flora briofitica di tutto il continente europeo. Una ricchezza straordinaria favorita dalla varietà di habitat e dalle condizioni ambientali, ma dovuta anche al fatto che la Svizzera è, di fatto, un anello di congiunzione ecologico fra l’Europa centrale e l’area mediterranea. Nonostante questo, oltre 1/3 delle specie di muschi in Europa e in Svizzera, sono a rischio o potenzialmente a rischio. Un team internazionale di ricercatori e ricercatrici ha sviluppato uno strumento in grado di identificare i muschi che hanno più urgentemente bisogno di aiuto per sopravvivere a lungo termine. Ne parliamo con Ariel Bergamini, uno dei massimi esperti di muschio in Svizzera. E… faremo una camminata con Lara Lucini, biologa del Museo Cantonale di Storia Naturale alla scoperta di alcune specie di muschi che crescono solo in Svizzera, solo nel luganese, solo... a Gandria!
Trecentosessantacinque chilometri quadrati di terra, stretta tra il mare e i confini, oggi ridotti in gran parte a macerie. Gaza è il simbolo di una devastazione che non ha risparmiato nulla: case, ospedali, scuole, nemmeno le università, cancellate fisicamente dai bombardamenti insieme al futuro di quasi novantamila studenti e centinaia di docenti.Eppure, in mezzo a tutto questo, c’è chi non si è arreso. Nei campi profughi, in spazi improvvisati, attraverso connessioni internet che vanno e vengono, ci sono stati ricercatori che hanno continuato a insegnare, a studiare, a raccogliere dati. È la scienza che si fa resistenza, la conoscenza che diventa un atto di dignità.Ma c’è anche un’altra storia che merita di essere raccontata: quella del silenzio. Un silenzio che, come ricorda l’esperto di salute pubblica globale Roberto De Vogli dell’Università di Padova, non è neutralità ma complicità. È il silenzio selettivo di tante istituzioni accademiche e scientifiche internazionali, pronte a reagire altrove ma rimaste in gran parte mute davanti alla distruzione del sistema educativo di Gaza: oltre il 90% delle scuole colpite, diciannove università distrutte o gravemente danneggiate, più di 190 accademici uccisi.Nel Giardino di Albert ascolteremo la sua voce e quella del fisico Mario Martone, del King’s College di Londra, fondatore di Scientists for Palestine, che da anni lavora per costruire ponti formativi al di là dei muri e delle barriere.Un racconto che intreccia scienza e diritti umani, ricerca e memoria, silenzi e resistenze. Perché se a Gaza muore la conoscenza, muore un pezzo di futuro che appartiene a tutti noi.
Un incontro pubblico alla Biblioteca cantonale di Locarno lo scorso 27 maggio è stata l’occasione per parlare con l’astrofisica italiana Patrizia Caraveo, nota per le sue ricerche nel campo delle alte energie cosmiche e delle radiazioni gamma, del suo libro Ecologia Spaziale, Dalla Terra alla Luna a Marte (Hoepli, 2024).Un grido d’allarme di fronte alla proliferazione incontrollata di costellazioni di satelliti che rischiano di rendere l’orbita terrestre un pericoloso far west, nel quale gli interessi economici e geopolitici dei più forti dominano lo spazio circumterrestre fino alla Luna e Marte. Una sfida epocale che va affrontata tenendo conto degli interessi di tutti gli attori, siano essi imprenditori della ormai fiorente space economy, agenzie spaziali di singoli paesi, enti internazionali che utilizzano i satelliti per l’osservazione della Terra e del clima o per le comunicazioni in senso lato.Quella che per Patrizia Caraveo sta diventando un’emergenza planetaria che non riguarda soltanto l’orbita attorno alla Terra, ma anche le conseguenze negative per l’intera atmosfera, implica da un lato la conoscenza dei dati nella loro globalità dall’altro – soprattutto - la riscoperta di un’ecologia spaziale che risale alle fotografie della Terra scattate dagli astronauti che tra gli anni 60 e 70 del secolo raggiunsero la Luna. Evitare il far west satellitare intorno alla Terra significa, in definitiva, scongiurare il pericolo di una imminente selvaggia “riconquista” della Luna e più in là di una pretesa colonizzazione di Marte.











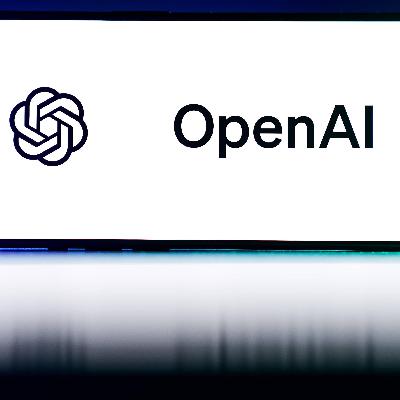

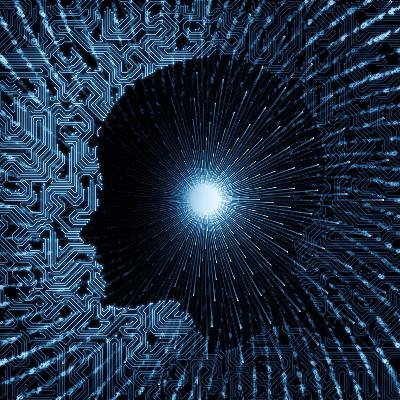







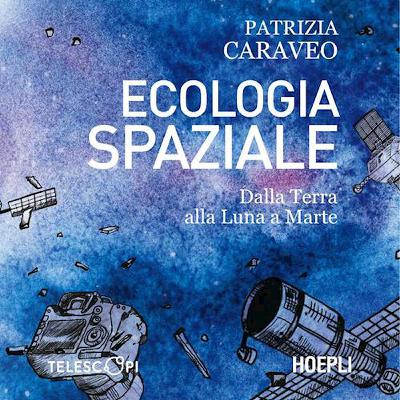



Sei di Locarno come me
latticini jogurt non dimostrati c'è fanno bene