Discover IntrAfrica
IntrAfrica
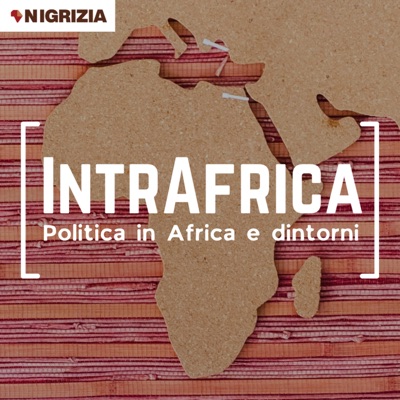
9 Episodes
Reverse
Promessa tradita o normale transizione politica in un sistema democratico? Se guardiamo in filigrana il declino dell’African National Congress che guida il Sudafrica da trent’anni, quale immagine emerge? Nel 1994 il Sudafrica guidato da Nelson Mandela riuscì in un miracolo politico: il secolo breve, quello dei genocidi e delle guerre mondiali, non si concluse con una nuova, terribile guerra civile. Il paese riuscì a superare, senza violenza diffusa, tre decenni di segregazione razziale istituzionalizzata, l’apartheid.
A 30 anni di distanza, il sogno di Mandela sembra appannato: l’Anc, consumato dalla corruzione, si dimostra incapace di soddisfare anche alcuni tra i bisogni più elementari della popolazione.
Mentre le disuguaglianze che rendevano possibile l’apartheid non sono state cancellate. Anzi. Ma le domande che ci stiamo ponendo non hanno risposte semplici: e a dimostrarlo potrebbero essere le stesse urne, che più che suggellare un fallimento potrebbero finire per battezzare una nuova, sicuramente complessa, coalizione di governo.
E che potrebbero provare quindi, che la lotta di liberazione non è un assegno in bianco per l’eternità.
E che il sistema democratico sudafricano, con tutti i suoi limiti, funziona.
Del Sudafrica che si avvicina al voto parliamo con Rocco Ronza, politologo, docente presso l’università Cattolica e Aseri e membro del programma Africa dell’Ispi.
Puntata a cura di Brando Ricci. Produzione audio: Roberto Valussi.
Questo podcast è possibile grazie al sostegno dei nostri lettori e ascoltatori. Per dare spazio a più contenuti del genere, puoi abbonarti a Nigrizia.
Per orientarsi nella puntata:
02:28 - Il lento declino dell’Anc
04:53 - La promessa tradita della rainbow nation?
06:39 - Che governo aspettarsi dalle elezioni?
11:04 - Il Sudafrica sempre più verso i Brics?
13:20 - L’ancoraggio a ovest del paese
15:58 - Cosa vogliono gli Usa
19:16 - La mina vagante Jacob Zuma
23:17 - Le critiche al ‘’compromesso storico’’ di Mandela
25:55 - La tenuta dell’icona Mandela
Ciad e elezioni: non una storia d’amore; semmai di formalità.
Il 6 maggio, i cittadini ciadiani saranno chiamati a votare per scegliere il Capo di stato. Ma le urne qui non determinano tanto il futuro. A contare di più sono la forza militare dei contendenti, le loro trame locali e internazionali.
In Africa subsahariana e non solo, ci sono tanti stati così, in mano a quelli che vengono definiti autoritarismi democratici, dei regimi autoritari con le parvenze di una democrazia. Allora, perché occuparci del Ciad, di cui si parla veramente poco? In primo luogo perché quello che succede qui influenza tutta l’area limitrofa, di cui l’Italia pare si stia accorgendo solo negli ultimi 2 anni, con l’ondata di golpe nel Sahel e il timore per un acuirsi della spinta migratoria.
Altri paesi s’erano accorti ben prima di noi del Ciad e del suo ruolo di cerniera tra Africa del nord e sub-sahariana. Al punto che la Francia ne aveva fatto un suo avamposto militare durante la guerra fredda.
Ma in tempi di declino della françafrique, avanzate russe e passi incerti americani, dove va il Ciad di oggi e come lo fa?
Affrontiamo tutto questo in collegamento con Alessio Iocchi, esperto di Sahel, ricercatore presso la Statale di Milano e docente a Napoli dell’Università Federico II e dell’Orientale.
Puntata a cura di Roberto Valussi.
Questo podcast è possibile grazie al sostegno dei nostri lettori e ascoltatori. Per dare spazio a più contenuti del genere, puoi abbonarti a Nigrizia.
Per orientarsi nella puntata:
01:51 - I vicini turbolenti del Ciad
04:12 - Ciad utile e Ciad inutile
07:02 - Il figlio d’arte del nepotismo: chi è Déby figlio
10:54 - Cugino, oppositore e eliminato: Yaya Dillo Djerou
13:00 - Laureato in matematica e pronto alla ribellione
14:41 - L’esecuzione di Kaka contro il cugino
17:25 - La fu speranza del cambiamento: Succès Masra
20:58 - Masra: l’opposizione cooptata
22:44 - L’oppositore di professione nell’autoritarismo democratico
26:01 - Il Ciad e la françafrique
28:55 - Cosa conta N’djamena per Washington
30:50 - La semplice strategia russa in Ciad
33:50 - Il Ciad nella guerra in Sudan
La storia di Isabel dos Santos è molte cose. Da una parte, rappresenta l’archetipo del concetto di “nepotismo”. Figlia primogenita dell’uomo che ha governato l’Angola per 38 anni, dal padre ha ricevuto in sorte quote e partecipazioni, fino al controllo, di numerose società statali. Le ha trasformate in un patrimonio da miliardi di dollari e in una rete di influenze politiche enormi. È diventata la donna più ricca d’Africa, la prima miliardaria del continente. È anche una storia di grande giornalismo però, quella di Isabel dos Santos. Di cronisti di numerosi paesi che si mettono insieme, esaminano tonnellate di carte e si ritrovano appiccicata alle mani la patina dorata che copriva una vicenda fatta prima di corruzione e furto ai danni di un popolo, che di grandi capacità imprenditoriali e fiuto per gli affari. Esattamente non si sa dove si trovi ora, Isabel dos Santos, ma i suoi beni sono stati congelati in Angola. E lo stesso è stato ordinato dalla giustizia britannica lo scorso dicembre. Avviene nell’ambito dei numerosi procedimenti giudiziari che sono partiti in almeno 4 paesi anche dopo le rivelazioni dei giornalisti.
Chissà quindi, se quella di Isabel dos Santos diventerà anche una storia di giustizia, di potenti che smettono di essere intoccabili e finiscono davanti ai tribunali. Invece di essere, come la stessa interessata denuncia a mezzo stampa, l’ennesimo regolamento di conti in un paese governato da 50 anni dallo stesso partito.
Ne parliamo con Paolo Biondani, giornalista dell'Espresso che ha lavorato sull'inchiesta internazionale dei Luanda Leaks.
Puntata a cura di Brando Ricci.Produzione e montaggio: Roberto Valussi.Questo podcast è possibile grazie al sostegno dei nostri lettori e ascoltatori. Per dare spazio a più contenuti del genere, puoi abbonarti a Nigrizia.
Per orientarsi nella puntata:
02:35 - Chi è Isabel Dos Santos
06:27 - Come è diventata la donna più ricca d'Africa
08:36 - Cosa sono i Luanda Leaks
12:20 - La latitanza di Isabel Dos Santos
13:49 - Il whistleblower dietro i Luanda Leaks
17:37 - La discutibile lotta alla corruzione del Presidente Lourenço
Gheddafi e i suoi viaggi a Roma, con tende e cammelli annessi. Oppure una nuova terra di lager per migranti. Sono due tra i principali pensieri che possono saltare in testa quando si parla di Libia.
Di questo paese complesso e strategico per tanti stati, incluso il nostro, sappiamo e ci occupiamo poco. È una sorta di buco nero, da cui estrarre petrolio e in cui bloccare migranti.
In questa puntata di IntrAfrica, tentiamo di mostrare il filo logico della Libia, del suo recente sviluppo politico e del suo presente bicefalo, diviso tra Tripolitania e Cirenaica.
Lo facciamo con un'intervista ad Antonio Morone, professore associato in Storia contemporanea dell'Africa e coordinatore del corso di laurea in Studi dell'Africa e dell'Asia presso l'Università di Pavia, nonché collaboratore di Nigrizia da molti anni, soprattutto sui temi libici.
Puntata a cura di Gianni Ballarini.
Produzione e montaggio: Roberto Valussi.
Questo podcast è possibile grazie al sostegno dei nostri lettori e ascoltatori. Per dare spazio a più contenuti del genere, puoi abbonarti a Nigrizia.
Per orientarsi nella puntata:
02:50 - Le origini della divisione est-ovest
06:26 - La spartizione delle risorse in un paese diviso
08:00 - La Banca Centrale come elargitore di guadagni
10:40 - Elezioni: il fallimento delle politiche del 2021 e il futuro prossimo
15:07 - Rischio disintegrazione per la Libia?
16:18 - Il Generale Haftar è fuori o dentro i giochi?
17:23 - Il peso delle milizie
19:32 - Quali potenze straniere agiscono in Libia
20:53 - Il ruolo dell’Italia
23:14 - Migranti: la collusione con i trafficanti
24:48 - La politica italiana di supporto alla Libia funziona?
Sono passati 30 anni esatti dall'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Giornalista la prima, cameraman il secondo. Freddati in un agguato a Mogadiscio, in una Somalia avvolta dalla guerra.
30 anni senza una verità giudiziaria. Non ci sono i nomi degli esecutori, men che meno quello dei mandanti. Addirittura non c'è un movente.
Eppure si sa quasi tutto.
Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto per tre volte la proposta della Procura di archiviare le indagini. E ufficialmente l'inchiesta è ancora aperta.
Sul caso ci sono davvero montagne di documenti. Se ne sono interessate cinque commissioni parlamentari. Sono state aperte inchieste, oltre che a Roma, anche ad Asti, Gaeta, Latina, Perugia, Reggio Calabria, Trapani, Milano, Udine.
Sono nati premi giornalistici dedicati a Ilaria e a Hrovatin e sono fiorite associazioni che portano il loro nome.
Ma alla fine, nonostante tutto questo e altro ancora, rimane un assassinio caduto nell'oblio, assieme ai mille depistaggi che questa storia porta con sé.
Parliamo di questa vicenda con Luciano Scalettari, giornalista tra i pochi, pochissimi, ad aver fatto indagini a riguardo. Ha scritto reportage, libri e ha fatto parte di una delle commissioni parlamentari che si sono occupate del caso.
Puntata a cura di Gianni Ballarini.
Produzione e montaggio: Roberto Valussi.
Questo podcast è possibile grazie al sostegno dei nostri lettori e ascoltatori. Per dare spazio a più contenuti del genere, puoi abbonarti a Nigrizia.
Per orientarsi nella puntata:
02:08 - Perché sono stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin?
03:35 - Non un affare di Stato, ma di Stati
08:17 - Quanto erano scomode le indagini di Ilaria Alpi?
11:28 - Come le inchieste giudiziarie sono state depistate
15:16 - L'uscita dalla Commissione parlamentare d’inchiesta
16:50 - Altre ipotesi giornalistiche?
18:28 - Che figure sono state i genitori di Ilaria Alpi?
21:35 - Le motivazioni dietro un lavoro di inchiesta durato decenni
È una questione tanto semplice quanto paradossale. In Africa 600 milioni di abitanti, circa la metà della sua intera popolazione, non ha accesso all’elettricità.
Allo stesso tempo, ha il più vasto potenziale di produzione di energia solare al mondo. Senza contare la possibilità di ricorrere ad altre fonti di energia rinnovabile, come l’eolica.
Quindi cosa trattiene questo continente dallo sfruttare le sue risorse? Perché, quando si parla di energia, ne sentiamo discutere perlopiù in termini di petrolio e gas? È una questione di tecnologia, di soldi, di instabilità politica? Di cosa?
Può il continente bypassare la fase di sviluppo industriale inquinante ben nota ai paesi industrializzati e saltare direttamente ad un’economia basata sull’energie rinnovabili? Come sta affrontando la transizione energetica?
Cercheremo di fare chiarezza su questo groviglio di domande con il professore Gianni Silvestrini, Direttore scientifico del Kyoto Club, esperto di energie rinnovabil, e vero e proprio punto di riferimento in Italia sul dibattito in materia. E fra l’altro sulle pagine di Nigrizia, scrive una rubrica mensile, L’aria che Tira, sulle questioni energetiche in Africa.
Per orientarsi nella puntata:
01:29 - Quanto si usano il solare ed eolico in Africa
05:10 - Perché l’energia solare e le fonti rinnovabili sono poco sfruttate
09:08 - Fonti rinnovabili e produzioni di energia su larga scala (industrie e reti elettriche nazionali)
10:48 - Prospettive per le rinnovabili
14:10 - Corsa al fossile degli stati africani
16:29 - L’importanza di stabilità politica per i finanziamenti
Un colpo di scena giudiziario alla volta, il Senegal si è avvitato su una crisi politica, istituzionale e sociale.
Fino a metà gennaio, il Presidente della repubblica Macky Sall, poteva apparire come un machiavellico maestro di cerimonia. Ora si ritrova a raccogliere i pezzi di una tossica e mal congegnata strategia di divide et impera nei confronti dell'opposizione.
Gli era quasi riuscito il compito di silenziarne le parti scomode e recuperare quelle, per lui, utili.
Non si aspettava, forse, di inciampare là dove si era sentito più a casa, finora: il settore della giustizia. Il Consiglio Costituzionale si è rivelato il contro-potere più netto alla sua autorità politica. Prima escludendo Karim Wade, ex-rivale trasformato in alleato per il secondo turno delle prossime (in teoria) elezioni presidenziali. Poi annullandogli il decreto del 3 febbraio con cui voleva rinviare le suddette elezioni.
Ora il Senegal annaspa, cercando un compromesso che possa far salvare la faccia a tutti i candidati (accettati o meno) alla corsa per le prossime elezioni presidenziali.
Ne parliamo, in collegamento da Dakar, con Marco Simoncelli, giornalista e fotografo freelance di base in Africa occidentale.
Per orientarsi nella puntata.
02:29 - Perché Macky Sall ha tentato di rinviare le elezioni
05:50 - Chi è Karim Wade e perché è tornato fondamentale
08:09 - L’ascesa di Ousmane Sonko
14:21 - La repressione del dissenso negli ultimi 3 anni
15:10 - Sonko e la religione
17:20 - Il divide et impera (et incarcera) di Macky Sall con l’opposizione
21:00 - Rapporto tra potere giudiziario e politico
22:11 - Cosa può fare Macky Sall adesso?
23:56 - Il fattore giacimento di gas e petrolio
25:21 - Rischio golpe
27:22 - Rapporto tra Francia e Senegal
#senegal #ousmanesonko #dialoguenational #mackysall #karimwade #bassiroudiomayefaye #dakar
I due generali continuano a contendersi i brandelli del Sudan, a dieci mesi dallo scoppio delle ostilità tra i due ex-alleati di governo.
Cerchiamo di decifrare le loro decisioni e se non il futuro, almeno il passato e il presente del paese.
Va da sé che lo sguardo va al gioco di influenze esterne. Da questo punto di vista, alcuni stati appaiono più attivi, come gli Emirati Arabi Uniti e di recente l'Iran.
Altri, come gli Stati Uniti e l'Unione Europea rimangono a guardare, ma hanno contribuito non poco a determinare la situazione attuale. I primi avevano sponsorizzato la riabilitazione di Khartoum, dopo anni della sua messa all'indice come stato canaglia. I secondi, quindi italiani compresi, avevano pagato per armi e addestramento alle vituperate Rapid Support Forces (ex Janjaweed) per controllare il flusso dei migranti.
Ma al di là degli attori stranieri, questa puntata si concentra sui fattori interni, a nostro avviso più rilevanti per comprendere cause, andamento ed evoluzione della guerra in corso.
Alla (giustamente) glorificata società civile sudanese, al momento resta poco spazio d'azione, in un momento in cui parlano le armi. Tuttavia, vale la pena tenere in conto le varie milizie armate che si aggiungono al panorama di attori bellici. Il conflitto in corso è sì dominato dalle forze dei due generali, ma non possiamo sottovalutare queste altre forze.
Approfondiamo tutto questo con Sara de Simone, collaboratrice di ricerca della Scuola di studi internazionali dell’Università di Trento, esperta di Sudan e di Sud Sudan.
Intrafrica è il podcast di approfondimento di Nigrizia su politica africana e dintorni.
Questa puntata è a cura di Brando Ricci.
Produzione e montaggio: Roberto Valussi
Per orientarsi nella puntata:
00:00 - introduzione
02:36 - dalla secessione del Sud-Sudan alla caduta di Bashir / 2011-2019
05:58 - la transizione democratica dirottata dai militari / 2019-2021
08:11 - il ruolo della società civile sudanese dal 2019 ad oggi
09:45 - le radici dello scontro tra al-Burhan ed Hemetti
12:18 - il Darfur come modello di conflitto su scala nazionale
13:51 - Né con l'esercito, né con le RSF - le altre milizie
15:54 - la società civile e i Comitati di resistenza
18:17 - il peso delle potenze internazionali
20:35 - il ruolo dei vicini regionali
22:25 - le prospettive di negoziati
24:12 - perché il Sudan non sta interessando all'Occidente
25:43 - Sudan e il controllo delle migrazioni
26:49 - nessun sostegno popolate per i due principali belligeranti
#sudan #intrafrica #darfour #alburhan #hemetti #hemeti #rapidsupportforces #RSF #SAF
L’Etiopia cerca il suo posto al sole nel Mar Rosso. Per farlo pare disposta ad attirare gli strali di tutti i vicini e non nel Corno d’Africa.
Al centro delle discussioni: l’accesso dell’Etiopia al porto di Berbera, secondo le clausole (ancora poco note) del Memorandum d’Intesa siglato con il Somaliland, regione secessionista della Somalia. In cambio, Addis sarebbe disposta, prima al mondo, a riconoscere la sovranità di Hargeisa, capitale di uno stato ‘’de facto’’.
Ovvia la reazione irata della Somalia. Nelle fila degli scontenti, vanno annoverati anche altri attori non secondari, come Egitto e Eritrea.
Eppure il Primo ministro Abiy Ahmed sembra pronto ad affrontare le collere degli uni e degli altri, pur di raggiungere l’accesso al mare, suo obiettivo strategico di lungo corso.
In questa puntata d'esordio del nostro nuovo podcast di approfondimento, cerchiamo di fare chiarezza con Luca Puddu, ricercatore in Storia dell’Africa, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo, già collaboratore di varie riviste, tra cui Limes e Nigrizia.
Per orientarsi nella puntata:
00:00 - introduzione
02:50 - contesto internazionale: ruolo Emirati Arabi Uniti, Cina e Egitto
10:36 - contesto regionale: ruolo Eritrea e Somalia
16:27 - contesto interno: gli Amara e gli Accordi di Pretoria 2022
20:39 - contesto interno: gli Oromo
22:05 - contesto interno: il Somali Regional State
24:31 - il ruolo del Somaliland
#Etiopia #Somalia #Somaliland #IntrAfrica #MarRosso #EmiratiArabi #politicaafricana #abiyahmed #oromo#hargesa #berbera #amara #tigray





