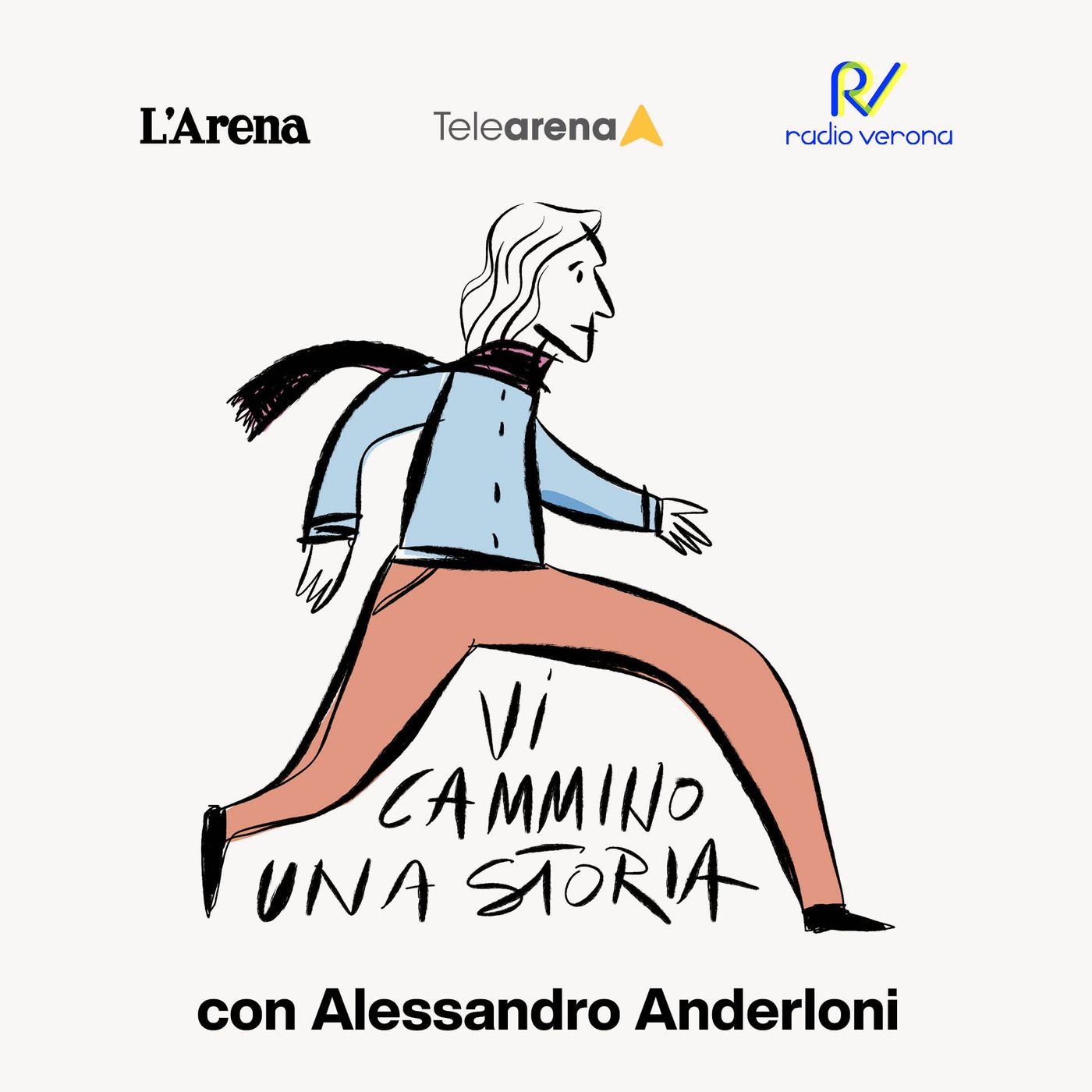Discover Vi cammino una storia con Anderloni
Vi cammino una storia con Anderloni

Vi cammino una storia con Anderloni
Author: Gruppo editoriale Athesis
Subscribed: 1Played: 3Subscribe
Share
© Gruppo editoriale Athesis
Description
Cantastorie “di professione” con il teatro, il cinema e la scrittura, Alessandro Anderloni percorre a
piedi ogni settimana un itinerario della provincia di Verona, dalla Lessinia alle Basse, dal Lago alle colline, nel cuore e nella periferia della città, per farsi voce di leggende, fiabe, fatti storici, personaggi della tradizione locale. Racconta l’anima profonda e antica della terra veronese, senza nostalgie, mostrandone i luoghi, respirandone i profumi, dialogando con i rumori.
piedi ogni settimana un itinerario della provincia di Verona, dalla Lessinia alle Basse, dal Lago alle colline, nel cuore e nella periferia della città, per farsi voce di leggende, fiabe, fatti storici, personaggi della tradizione locale. Racconta l’anima profonda e antica della terra veronese, senza nostalgie, mostrandone i luoghi, respirandone i profumi, dialogando con i rumori.
18 Episodes
Reverse
Sulle mappe c'è scritto Azzarino, ma i montanari la chiamano Adarin questa conca di alture e piccole valli, di prati, pascoli e faggete protetta a sud dal Monte Purga, a nord dai pascoli che salgono alla Beloca e chiusa a est dallo sprofondare della Val d'Illasi. Alla prima (e ultima?) nevicata dell'inverno mi incammino sulla strada che unisce le contrade di questo che fu uno degli antichi Tredici Comuni Cimbri delle Lessinia, le comunità in cui si riunirono i coloni bavaro-tirolesi giunti nel Medioevo, quando portarono quassù, assieme alla loro arte di boscaioli e carbonai, anche la lingua alto-tedesca chiamata Cimbro.Le contrade di Azzarino si sono salvate (ma si salveranno?) dalle lottizzazioni e dai restauri scriteriati. A osservare i tetti di pietra imbiancati dalla neve, pare di camminare dentro a un presepio. In questi giorni, sulle credenze delle case, con poca farina sopra al muschio, si faceva in ogni casa il presepio: il simbolo più tenero della nostra fede. Delia e i suoi tre bambini vivevano nella più isolata di queste case, racconta la storia. Da giorni nevicava e la donna non aveva più niente da dare da mangiare ai suoi bambini, non aveva legna per accendere il fuoco nel camino e le rimaneva solo una vecchia e lacera coperta di lana. Giungo alla cappellina prima di contrada Tece. Qui avevano le loro sentinelle i partigiani di Giuseppe Marozin, comandante fuorilegge che scelse queste contrade isolate per farne il suo rifugio, nell'estate del 1944. E qui i partigiani catturarono un giovane soldato tedesco in fuga, che venne poi ucciso, come la maestra di Tregnago, il figlio di un "fascista" vicentino e un giovane partigiano, tutti e quattro sepolti in un bosco che da allora i montanari chiamarono il Bosco dei Morti. La neve fiocca lenta e ricama ogni cosa di bianco. Ai Battistari si posa sulle lastre che delimitano la carrareccia che conduce alla piccola scuola. I bambini e le bambine la raggiungevano a piedi, che fosse sole, pioggia e neve, e d'inverno portavano con sé una stèla, un ceppo di legna per la stufa della pluriclasse dove una maestra insegnò fino agli anni Sessanta. I figli di Delia no. Loro non potevano portare legna per la stufa della classe: non ne avevano nemmeno per scaldare la loro povera casa. In contrada Foi il vento si alza. Lino mi apre la porta di casa e mi invita a bere il caffè, corretto con abbondante e corroborante grappa. E racconta, come si fa quando nevica, perché la neve ferma il tempo, lega il passato con il presente, rinsalda i legami di una comunità. Qui, ai Foi, viveva il Mago Foeto che nella sua casa custodiva il proibito Libro di Pietro D'Abano; qui avevano il loro "quartier generale" i partigiani di Marozin e, poco più avanti, nel bàito della Riva, custodivano quello che rubavano alla gente.Al Campe c'è Gabriella a invitarmi in casa. «In do veto in giro co sto tempo?», mi chiede stupita. Finché anche lei mi prepara un altro caffè, cammino per questa contrada dove negli anni Cinquanta vivevano più di cento persone, ora ne è rimasta soltanto una. Sgorga dalla fontana un'acqua pura, limpida e fresca che ha dissetato e fatto crescere forti e sane generazioni di montanari, ma qualcuno vi ha apposto un insulso cartello con scritto "acqua non potabile". Ricordo d'aver visto anche delle pietre con scritto PP: Proprietà Privata. Chi le ha messe non sa che le corti, quassù, sono di tutti: nessun montanaro si sognerebbe mai di delimitare la propria proprietà.Proseguo per la Cóal. Davanti alla sua casa, ricordo quando Elvira, l'ultima a vivere qui, si fermava sulla porta, con il volto antico come quelle pietre. E tra queste case immagino Delia camminare con la testa bassa, portando con sé un pentolino vuoto e chiedendo un po' di latte per i suoi bambini, per poi scomparire nella bufera, verso la sua casa. Dietro alla Cóal la neve ha trapuntato con una trina sottile la corona di spine del Cristo scolpito sulla stele di pietra, ha ricamato un fine merletto sui rami dei faggi che avvolgono la carrareccia verso il Pozze. Quando inizio la salita per raggiungere i Senoti, il vento e la neve mi sferzano il volto, mi fischiano nelle orecchie, mi appannano la vista. «L'è vento e neve», dicono i montanari, e quelle due parole significano molto più di una bufera: sono qualcosa che si muove, che si mescola, percuote, urla, schiaffeggia, colpisce, batte. «El fa le sgoldere», si dice ancora. Come si può tradurre la parola sgoldera? Non è un cumulo, non è un riporto di neve. È una lama, una spada, una grondaia, una nube di neve. Quando avremo dimenticato definitivamente queste parole in dialetto, preferendo loro uno sciatto italiano, allora scomparirà per sempre anche ciò che esse indicano.Giunta a casa appena in tempo per non essere dispersa nella bufera, Delia diede ai suoi bimbi il latte che le avevano donato e intiepidì la stanza con l'ultimo ceppo di legna rimasto. Nevicò per giorni e giorni: la donna non avrebbe potuto chiedere aiuto e nessuno sarebbe salito fin lassù. Si preparò allora a morire con i suoi bambini, quando all'improvviso sentì bussare alla porta. Andò ad aprire e si trovò di fronte un mendicante che chiedeva la carità, ma la donna non aveva niente: cosa poteva dargli? Lui fece per andarsene, allora lei si tolse le calze di lana rattoppate e i consumati zoccoli di legno e gli donò quelli. Voleva dargli anche l'unica coperta che le restava, ma l'uomo non la prese. Guardò la donna e i suoi bambini e uscì nella bufera.La contrada Senoti è una delle più alte di Velo. Silvano l'ha restaurata lasciando i sassi facciavista, recuperando le vecchie lastre del pavimento, il focolare, il secchiaio, le porte. Così, senza impianto di riscaldamento, è possibile immaginare quanto fosse coriacea la scorza dei montanari che vivevano in questi luoghi che ora ammantiamo di poesia ma che un tempo significavano freddo, fatica, privazione. Accanto al focolare, penso a Delia guardare i suoi bambini, quand'ecco che i piccoli si accorsero che nel camino ardeva un vivace fuoco e che sotto la coperta che l'uomo aveva lasciato in un angolo ora c'erano pane, latte, farina, salami, e c'erano calze, pantaloni, maglioni, berretti e sciarpe. La donna allora capì che quel mendicante non poteva che essere un angelo venuto a salvarli. Uscì di casa a piedi nudi, e corse, affondando nella neve, seguendo le impronte di quell'uomo, per raggiungerlo e ringraziarlo. Ma, ad un tratto, quelle impronte sulla neve scomparvero. Delia alzò gli occhi al cielo, da dove un raggio di sole spuntò tra le nuvole a illuminare la grande distesa bianca.
Una produzione Telearena.«Santa Lucia, pòrteme un caretin». Nella chiesa di Santa Lucia Extra, sotto l’altare della vergine martire di Siracusa, in una grande bottiglia ci sono le lettere a Santa Lucia. Di buon mattino, prima dell’inizio della scuola, i bambini e le bambine entrano in chiesa per lasciare lì la loro letterina, la stessa che scrisse anche Renzo Poffe, pittore e poeta, quando, il 12 dicembre di tanti anni fa, chiese alla Santa di portargli un caretin.Prendo in prestito la sua storia per immaginarmi un bambino di nome Renzo partire a piedi con la mamma dal quartiere di Santa Lucia per andare in Piazza Bra. Non solo per visitare i Banchetti di Santa Lucia, ma per tenere fede al voto di camminare fino alla piazza in cui, nel Medioevo, i bambini giunsero per chiedere alla santa ausiliatrice della vista di guarirli dalla malattia agli occhi che li affliggeva.La statua della martire guarda la piazza, dall’alto della facciata di questa che è la sua chiesa in città. Ma la storia del culto di Santa Lucia a Verona è lunga e complessa. L’oratorio che venne costruito qui nel 1518 non fu il primo. Ce n’era un altro più antico che si trovava intra (dentro) le mura della città. Quella che nel quartiere di Santa Lucia possiamo vedere oggi è invece la chiesa che don Pietro Cunego fece erigere a fine Ottocento. Il capitello all’incrocio tra Via Mantovana e Via VI Maggio ha le forme della cella campanaria del suo campanile.Immagino Renzo fermarsi davanti al capitello e fare il segno di croce, per poi proseguire sulla strada verso il centro. La maestra gli aveva spiegato che quello era il tracciato di un’antica via romana chiamata Postumia e che a testimoniarlo, poco più avanti, avrebbe trovato un sasso dallo strano nome: cippo gromatico. Oltre il cippo, un muro sbarra oggi l’antica via consolare romana: prima il Forte Werk Schwarzenberg e poi il deposito delle locomotive vennero costruiti a interromperne il tracciato. Per proseguire verso Piazza Bra, Renzo e sua mamma avranno dovuto prenderla larga e, come devo fare io, passare sotto alle linee ferroviarie. A stento respiro nei sottopassaggi. Il rumore del traffico è assordante. Mi chiedo come doveva essere diversa, più silenziosa e quieta, questa periferia, a inizio Novecento. E dove doveva trovarsi l’antico oratorio di Santa Lucia che nel 1308 un drappiere di nome Pace, mercante di lana, fece costruire per voto, dopo che la Santa lo aveva guarito da una mortale cancrena alla gamba.La storia delle chiese dedicate a Santa Lucia a Verona è di continue costruzioni, demolizioni e ricostruzioni. Secondo i documenti, un primo oratorio era stato eretto nel 973. Nel 1178 vi era annesso un ospedale gestito da frati. Tutto venne distrutto nel 1260 dalle scorrerie di Ezzelino da Romano. Ricostruito da Pace il drappiere nel Trecento, dopo due secoli anche questo oratorio venne raso al suolo quando, al termine della Guerra della Lega di Cambrai, nel 1518 il Doge di Venezia Andrea Gritti ordinò di “spianare” tutto, case e alberi, nello spazio di un miglior intorno a Verona. Anche l’oratorio di Santa Lucia, che si trovava nella fascia della così detta Spianà, venne demolito.Raggiungo l’austriaco Forte Santo Spirito che anch’esso venne costruito su questo lembo di terra spianata, come pure la nuova porta che Sanmicheli progettò per rimpiazzare quella delle mura scaligere. È risalendo Stradone Porta Palio che trovo ciò che rimane dell’altra chiesa dedicata a Santa Lucia, quella intra moenia, dentro le mura. Il convento costruito qui nel 1743 venne manomesso dalle truppe napoleoniche e infine bombardato nella Seconda Guerra Mondiale. Ciò che rimane oggi è la facciata, incastonata tra gli edifici militari.La mamma di Renzo, passando di lì, spiegò al bambino che quella era l’antica chiesa di Santa Lucia dentro le mura. Fu allora che lui le chiese perché la Santa porta i regali ai bambini, nella notte del 12 dicembre, e lei glielo raccontò. Tanti anni prima, i bambini e le bambine di Verona camminarono scalzi fino alla chiesa di Sant’Agnese, in Piazza Bra, per chiedere alla santa di Siracusa di guarirli da una terribile malattia agli occhi. Ma era un freddo inverno e i bimbi recalcitravano a camminare senza scarpe. Allora le mamme promisero loro di chiedere a Santa Lucia di ricompensarli di quel sacrificio con dolci e regali. È da allora che la Santa visita a una a una le loro case e porta loro i doni, per ringraziarli di quel pellegrinaggio. Ed è da tempo immemore che il 10 dicembre, arrivavano puntuali in Piazza Bra i venditori di dolciumi e di giocattoli, con i loro pittoreschi banchetti che sono il vero, autentico, popolare mercatino della nostra amata Verona che troppo spesso cerca scorciatoie turistico-commerciali, dimenticando che, fino a ieri, era solo un paese.
Una produzione TelearenaEra nato nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1929, nei giorni in cui il mondo contadino festeggia (non commemora) i Santi e i Morti. È la festa della vita, della speranza che ci sia, da qualche parte e in qualche modo, un altrove, per farci trovare pronti di fronte al mistero della morte. Noi, invece, imponiamo ai nostri bambini un’insulsa e inquietante mascherata commerciale, il 31 ottobre, travestendoli da mostri e streghe per stupirci poi se crescono con una cultura della morte e non della vita. È che noi abbiamo dimenticato chi siamo e da dove veniamo. Dino Coltro no. Lui lo sapeva bene e non smetteva di ricordarci che siamo tutti figli dello stesso mondo, contadino e cristianoCammino nei giorni che per i contadini segnano l’inizio dell’anno agrario. Dalla Strà di Coriano, dov’era nato dopo tre giorni di travaglio, il passo è breve per arrivare a Corte Pilastro. Quando mi appare il portale d’ingresso, in fondo al lungo viale, penso alle parole di Coltro quando, a un altro studioso della civiltà veneta, Eugenio Turri, confidò: «Se, quando sarò morto, vorranno farmi una lapide, dovrebbero metterla nella Corte del Pilastro, dove sono cresciuto, con su una scritta “qui sono stato felice”». C’è, all’ingresso, una lapide installata dal Comune di Bonavigo, ma senza quella frase che avrebbe tanto da insegnare.La pianura veronese è ancora terra di giovani contadini. Al Pilastro mi accolgono curiosi e sorridenti. Sono felici che io racconti di Dino Coltro, il cui ricordo aleggia vivo tra le stalle, la barchessa e la casa padronale della corte. Già a otto anni Coltro lavorava qui, insieme con il papà Augusto e il nonno Moro da cui raccolse i ricordi che ispirarono il suo primo libro: I leori del socialismo. Lavorava, come tutti i bambini, non come schiavo, ma come figlio di una comunità educante se è vero, come dice il detto, che «ci vuole un intero paese per allevare un bambino».Nonno Moro gli raccomandava: «Studia se te vo cambiar el mondo». L’incontro, fortuito, con un frate questuante, fece sì che Dino potesse frequentare prima le scuole elementari a Bonavigo e poi le medie a Riva del Garda. La guerra interruppe i suoi studi regolari, ma da privatista superò l’esame di quinta ginnasio, frequentò il Liceo Cotta di Legnago e si guadagnò infine la licenza magistrale al Montanari di Verona. «Manco male che no’ ò laorà par gnente», gli disse la madre, alla notizia che era diventato maestro.Alla Moggia, dove un tempo l’Adige deviava per scorrere verso Este e Montagnana e sfociare in mare vicino a Chioggia, percorro le alzaie su cui immagino cavalli ansimanti a trascinare carretti, carriolanti a portare ghiaia, barcaioli a navigare sul fiume. Nel 1949, quando il padrone di Corte Pilastro trasferì tutti i salariati a Corte Rivalunga, Coltro e la sua famiglia attraversarono il fiume in traghetto, perché il ponte che collegava Bonavigo a Roverchiaretta era stato abbattuto dai bombardamenti.«Da queste parti sono i fiumi che comandano», scrisse Coltro. Lungo il fiume trovo un totem del percorso Sulle tracce di Dino Coltro alla scoperta della Pianura Veronese. È il decimo di un itinerario che si snoda per 75 chilometri nei paesi di San Giovanni Lupatoto, Zevio, Ronco all’Adige, Isola Rizza, Roverchiara, Palù e Oppeano. Raccoglie parte dell’eredità del titanico lavoro di ricerca che Coltro iniziò negli anni Cinquanta, registrando le testimonianze della cultura contadina: la sua missione di vita. Sugli scaffali di chiunque voglia studiare questa terra, dovrebbero esserci i cinque volumi di Paese perduto pubblicati tra il 1975 e 1978 dall’ispirato e lungimirante editore veronese Giorgio Bertani. Coltro trascrisse detti, modi di dire, proverbi, sentenze, cantilene, favole, aneddoti, soprannomi e storielle in dialetto, una lingua che canta e narra, che ride e piange, che è la parola creativa da cui nascono la favola e il mito. Con Pasolini, Coltro individuava nella progressiva scomparsa dei dialetti in Italia, la distruzione dei valori secolari della civiltà contadina. E con il dialetto scomparvero le corti, come Corte Medon che mi intenerisce di malinconia, dopo Roverchiara. Ma forse è giusto che finisca così,che restauri bizzarri non vengano ad accanirsi terapeuticamente su edifici che hanno diritto di morire.
Pastorale, canna da pesca e mànego per giocare a s-cianco. San Zeno, nella sua basilica, mi guarda e sorride. Sta certamente pensando alla rocambolesca partita con il diavolo Bandindon. Quella volta il demonio, sconfitto dal vescovo moro, fu costretto a volare a Roma a prelevare la coppa di porfido rosso che ora si trova all'ingresso della chiesa, dove un tempo era custodito il Carroccio della Lega Veronese. Sul suo fianco sono impressi i segni delle unghiate del diavolo. Sempre in lotta San Zeno e il demonio. L'acerrimo nemico del vescovo non si rassegnò nemmeno dopo la sua morte, quando volle impedire che le sante spoglie riposassero nella nuova cripta. Nell'807 dovettero scendere dal Monte Baldo due santi eremiti, Benigno e Caro, per traslare la salma, ché la semplice fede dei poveri è più forte dell'ostenta ricchezza di arcidiaconi, vescovi e re. Sulla facciata del capolavoro romanico si leggono non solo i racconti del Vecchio e del Nuovo Testamento, della liberazione di Adelaide di Borgogna e della caccia di Re Teodorico, ma anche i segni della storia popolaresca di questo rione. Gli strani tagli sulle lesene accanto al protiro furono lasciati dai soldati romano-barbarici che usavano affilare le loro spade su queste pietre. Sugli altorilievi accanto al portale ci sono invece singolari incavi tondi. Non sarà stato Minico Bardassa e gli altri monelli cantati da Berto Barbarani a lasciare impresse sulla facciata della basilica queste coppelle levigate. Par di vederli, i ragazzacci, giocare a pallone sulla piazza, e ogni tanto tirare la palla oltre la piera del gnoco (o tàola dei pitochi) su cui, grazie al lascito del medico Tommaso Da Vico, il Venerdì Gnocolaro dodici poveri del quartiere potevano mangiare gnocchi a sazietà. Capitava allora che il pallone finisse dentro all'Arca di Re Pipino, dove i sanzenati volevano dormisse sogni eterni il figlio di Carlo Magno, così che i mocciosi dovevano recuperarla scendendo nel sottosuolo, attenti a non svegliare il sovrano sepolto. Le ha raccolte e trascritte Giuseppe Rama queste e le altre Storie de San Zen, che noi le avremmo dimenticate e non saremmo qui a camminarle. «Lassa che i zuga... dopo i morirà», dice la chiesa, con le parole del poeta, al suo moroso campanile, geloso e infastidito dal chiasso dei bambini sulla piazza. «Ho visto i pari de so pari, i noni / de so noni zugar sempre così...», prosegue ancora la basilica, adusa da mille anni a sopportare le pìrole di legno battute da Minico Bardassa e da tanti disgraziati come lui. È ben contenta di guardare i bambini giocare sulla piazza (ma ci sono ancora?) se perfino San Zeno, un giorno, sfidò a lippa il diavolo Bandindon.
Partiva da Fane alle 11 di mattina, la Mariolina. Aveva dieci anni, e nei giorni di vacanza toccava a lei portare da mangiare a suo papà, el Siena, che lavorava nelle Preare di Prun. A mezzogiorno doveva essere di là della valle. Parto anch’io, all’alba, e dalla chiesa di Fane mi infilo giù, ad attraversare le vie di un paese che non ha una piazza, le cui case dai tetti di pietra si distendono sul fianco del vaio. Si chiamano così le incisioni profonde che tagliano la Lessinia verticalmente, più strette di una valle. Questo, per gli abitanti di Fane è il Vaio de Prun, per quelli di Prun il Vaio de Fane, come se nessuno lo volesse. Dall’altra parte, nel primo sole, mi sento guardato dagli occhi neri delle preare. Le hanno sempre chiamate così: Preare di Prun. Forse perché in latino praebere si può tradurre anche cavare, o perché la pietra, quassù, è la pria. A chiamarle Cave di Prun si iniziò in tempi recenti, per il nostro vezzo di italianizzare i toponimi dialettali, come se volessimo liberarci di un passato che ci interessa sempre meno.Il sentiero che scende tra i faggi e i carpini è un ristoro dell’anima. Sento lo scroscio del torrente. L’acqua è chiara, fresca e dolce, parafraso, con le parole del poeta. E penso alla Mariolina che, con le altre bambine di Fane, con le sgalmare di legno scendeva e risaliva il vaio, per nulla spaventata dalla fatica, ché i bambini erano abituati a camminare. E camminando parlavano, giocavano, cantavano, e crescevano, più sani e robusti, forse anche più felici. Nella sporta de paia la Mariolina portava una ramineta con dentro il minestrone o la pastasciutta, un tegamino con patate o broccoli, e poi salado o bóndola o formaio, con du paneti e, in una bottiglia, un po’ di graspia: il vino dei poveri, in questa valle che ora produce e vende vino pregiato ai ricchi di tutto il mondo.Ti viene voglia di correre, sul sentiero che saltella di qua e di là del fosso. Correva la Mariolina, e le capitava così di spandere un po’ di minestra tanto che, arrivata alla fontana della Vallecchia, la allungava con l’acqua, sperando che el Siena non se ne accorgesse. La strada che sale da contrada Castello è delimitata da un lato dalle lastre verticali conficcate a terra, dall’altro dai muri a secco, con pietre incastrate a lisca di pesce. La prima preara che incontro è quella dei Russi, l’altra, custodita con amore dall’Associazione La Malga, del Spadon. Illuminati di taglio da una lama di sole, sui pilastri che sostengono le volte di pietra sono perfettamente leggibili i 73 strati di lastre che la Natura ha fornito all’Uomo già tagliati, pronti per essere estratti e messi in opera. Si tratta di Scaglia Rossa Veneta o lastame del Cretaceo. La chiamano, da secoli, Pietra di Prun, anche se commercialmente funziona di più Pietra della Lessinia.Fa girare la testa pensare che questa pietra si è formata cento milioni di anni fa, quando queste terre erano coperte dalle acque dell’Oceano Tetide, con un impasto di detriti, conchiglie, frammenti di molluschi e altri organismi marini che si depositarono e compattarono sul fondale. Come una spugna, da questi strati l’acqua in milioni di anni fuoriuscì, lasciando a dividerli sottili veli di argilla. I cavatori a ogni strato avevano dato dei nomi di fantasia, ma che rendono bene l’idea: la pietra di qualità era el meion, quella meno pregiata la lóa; quella che si lasciava cavare facilmente era zentil, quella difficile da cavare rabiosa; a seconda della pigmentazione si distingueva el biancon, el rosson e la lóa rossa, a seconda dell’utilizzo la piera da querti, la piera da seciar e la lastina. Gli amici dell’Associazione La Malga hanno recuperato un antico carro con cui buoi e cavalli trascinavano fuori dalle cave le pesantissime lastre di un metro per quattro, e, dentro alla cassetta di legno, gli attrezzi dei cavatori e degli scalpellini: ponte, massete, ponceti e bociarde. C’è anche una lampada a carburo. Quando entro nella cava, la luce calda della tremolante fiamma e l’inconfondibile odore dell’acetilene mi riportano a un tempo irrimediabilmente perduto.Iniziato nell’Età del Ferro, continuato con i Romani, poi nel Medioevo, nel Rinascimento e nel Settecento, l’utilizzo della Pietra di Prun fiorì negli anni Venti, quando in queste cave lavoravano duecento persone, tra cui el Siena, che frequentava anche la scuola per scalpellini di Prun. Alcune cave chiusero negli anni Trenta. Dopo la guerra ci fu una ripresa: serviva pietra per ricostruire Verona. Con l’inizio dell’escavazione a cielo aperto a Sant’Anna d’Alfaedo, negli anni Cinquanta, a poco a poco vennero dismesse, fino alla chiusura definitiva nel 1957.Mi addentro, tra le colonne di una cattedrale di pietra. Brilla alla luce del carburo, in una vascone, l’acqua con cui gli esperti forgiatori tempravano le punte. Sui bancali, così vengono chiamate le pareti, si leggono gli strati delle lastre e le mani dei cavatori che le hanno cavate, scolpendo da destra a sinistra e, i mancini, da sinistra a destra. Sotto una nicchia con un crocifisso e la data del 1955, tutto è rimasto come nell’ultimo giorno di lavoro: le lastre pronte, sui rulli di legno, con il foro per la leva che li faceva rotolare. Ci sono ancora i ponceti sotto una lastra già tagliata. Mi pare di vedere i cavatori, impolverati, seduti sulla loro cassetta di legno, a dare martellate. Quanta fatica! Uscendo, abbacinato dal sole, penso alla fame che doveva avere el Siena, quando a mezzogiorno rimproverava la Mariolina allorché arrivava qualche minuto in ritardo. Quella volta che lei portò del cibo che a lui non piaceva, el Siena buttò tutto nel bosco, per poi guardare la figlia, pentirsene e andare a raccoglierlo, mangiando quello che restava.Scendo da Prun verso Torbe, osservando i muretti, le case, le torri colombaie, le fontane e i lavatoi di pietra. Questa valle è stata modellata dalle mani di uomini rudi che alle parole preferivano i gesti, all’indolenza la tenacia. Ci hanno lasciato edifici che trasudano bellezza. E noi, cosa lasceremo? In contrada Mospìgolo in un cantiere di restauro si riutilizzano le antiche pietre. Ecco, forse abbiamo finalmente preso coscienza del valore di questa architettura vernacolare.Concludo il mio camminare là dove il Vaio di Prun (o di Fane) diventa Valpolicella, alle porte di Negrar. Grandi tensostrutture proteggono gli scavi archeologici della Villa Romana. Il portico, l’area termale, le vasche per la vinificazione e le lastre che contornano i preziosi mosaici sono state cavate proprio lassù, nelle preare: monumenti alla memoria.
Sulla piazza di Menà si può compiere un viaggio a ritroso nel tempo: la nuova chiesa degli anni Settanta, la vecchia chiesa ottocentesca, ormai in rovina, l’antico oratorio del Cinquecento dedicato a Sant’Anna. Lassù, dalla lanterna del campanile che svetta sulle tre chiese, vengono sette rintocchi di campane a risvegliare un silenzio sospeso tra il qui e ora e qualcosa di lontano e antico. Sono sceso fin quaggiù, nell’ultima propaggine della provincia veronese prima del rodigino, a cercare storie di briganti.La chiamano anche Menà di Vallestrema. Una terra estrema, dunque. Non mi sorprende che su questi campi, tra i canneti delle paludi, lungo gli argini dei canali, al riparo dei pioppeti, si dessero alla macchia briganti i cui nomi sono stati custoditi dall’immaginario popolare, pronunciati e tramandati di racconto in racconto.Era l’inizio dell’Ottocento, il “secolo dei briganti”, e se nel Regno di Sicilia c’era Pasquale Bruno, che ispirò Alexandre Dumas, in Abruzzo Pronio, a Napoli, Sciarpa, Fra Diavolo e il Taccone, nello Stato Pontificio Gasparrone, in Romagna Stefano Pelloni, detto Il Passatore, in Lombardia Paci Paciana e nel veronese non si era ancora spenta la fama del brigante Falasco, vissuto due secoli prima, qui si muovevano Giaron dela Menà, Petiol da Spinimbecco, Balin e il leggendario Nineta, il più temuto e ricercato. Mi perdo in questa campagna. La tangenziale che corre parallela all’Adige mi sbarra la strada, invalicabile più del fiume. Guardo un casolare di mattoni rossi, semicoperto dalla scarpata del cavalcavia, e, a circondarlo, i regolari filari di pioppeti che ombreggiano di un insolito sole novembrino. Tutto, quaggiù, evoca il ricordo di un mondo contadino scomparso.Alla Cà Vecchia un capitello mi riporta l’eco della fede dei poveri che, con la fine della Repubblica di Venezia (a fine Settecento) insieme ai Francesi videro arrivare nuove tasse, requisizioni di beni per soddisfare le necessità dell’esercito e arruolamenti obbligatori di giovani mandati in giro per l’Europa a combattere le guerre di Napoleone. Quando, a Castagnaro, si assistette alla chiusura voluta dai Francesi delle congregazioni della Beata Vergine e di San Francesco d’Assisi e alla requisizione e svendita dei beni comunali, la gente si ribellò. Nel 1806 i briganti assaltarono il municipio e, devastatolo, bruciarono in piazza tutte le carte e i registri con cui chi comandava vessava i poveri, sempre più poveri.Ma ora cammino verso l’Adige. Alle porte di Castagnaro le sue acque defluivano in un canale chiamato Diversivo. Per controllarle, i Veneziani costruirono a fine Settecento il così detto Ponte della Rosta. Dall’argine su cui poggiano i suoi contrafforti, scendo allo specchio d’acqua del fiume che oggi, gonfio, pare un lago. Questa lama rifrangente il cielo divide la pianura veronese e mantovana da quella rodigina e padovana. Un confine invalicabile? Tutt’altro. Gli scambi, anche un tempo, erano frequenti e consuetudinari, grazie ai barconi che univano le due sponde. A Brazzetto, tra Begosso e Carpi, ne furono rubati sei che servirono a dei disertori per fuggire alle caserme austroungariche e così non essere mandati in guerra e piuttosto diventare briganti. Ieri, come oggi, i giovani disertano le guerre: possiamo davvero chiamarli traditori?Percorro il tracciato dell’antica Strada Bassa di Vigo che proseguiva fino a Badia Polesine. I briganti, che non dobbiamo immaginare certo come “ladri gentiluomini”, organizzati in bande assaltavano le diligenze e non disdegnavano depredare le case, come fecero nel 1809 a Villa Bartolomea. Corso Fraccaroli è un velario scenografico su cui sono dipinte, nel sole autunnale che le illumina come un proiettore teatrale, la chiesa di San Bartolomeo, la Biblioteca Comunale, il Teatro Sociale, le scuole elementari (torniamo a chiamarle così e aboliamo quel repellente Primarie!) e il municipio. È nel suo archivio che Francesco Occhi ha scovato le carte che dicono dell’assalto dei briganti nel 1809, quando requisirono quattro buoi, intimarono il sindaco di dar loro pane, formaggio e vino e rapirono perfino un gruppo di cittadini per portarli, prigionieri, a Legnago. È tra queste carte che venne rinvenuto il mandato d’arresto di 1822 di tale Francesco Neri, detto Nineta.«Te gh’en fe pì de Nineta», si dice ancora oggi a qualcuno che si prodighi a combinare guai. E chi lo sapeva che Nineta non era una ragazzina pestifera, come ho sempre immaginato, ma il nome di un famigerato brigante delle Basse?Nato a Isola Porcarizza (l’antico nome di Isola Rizza) Nineta appare nella descrizione del documento che ne chiede l’arresto come un giovane snello dai capelli lunghi e ricci, con fazzoletto rosso e tabarro bianco. Un brigante vestito di bianco: immagine leggendaria! E la leggenda vuole che Nineta, che usava assaltare le carovane da solo fingendosi a capo di una banda, non fosse mai stato arrestato, anche se sull’atto di nascita di suo figlio, il parroco scrisse che il padre si trovava in carcere nel padovano, dove morì, forse nel 1831.Percorro, in compagnia del suo ricordo, la strada che porta a Vigo dove, nel 1809, una guarnigione francese mise in fuga i briganti che avevano assaltato Villa Bartolomea. Petio da Spinimbecco venne ucciso, Giarol dela Menà venne trasportato con gli altri briganti a Legnago. La città mi appare dall’argine del fiume che l’ha generata e che storicamente la divide. Osservo, in Via Leopardi, gli ultimi lacerti delle antiche mura, sviliti in muro di cinta di un parcheggio. Immagino Porta Ferrara, dove ai piedi dello spalto vennero fucilati i briganti. E rimpiango la stella che Michele Sanmicheli progettò a proteggere la rocca, quando vennero ricostruite le antiche mura del X secolo.Delle quattro torri circolari erette nel Quattrocento rimane solo il Torrione. La sua statuaria imponenza fa immaginare come doveva apparire questa città fortificata che, tra fine Settecento e fine Ottocento, fu prima veneziana, poi francese, poi austriaca, infine italiana. Ognuno dei nuovi arrivati si proclamò, manco a dirlo, liberatore. La Storia è dunque piena di liberatori dai quali saremo, presto o tardi, liberati.Camminando sull’argine, nel sole che tramonta dietro al Monumento ai Caduti, canticchio la filastrocca tanto cara ai briganti: «Co Venezia comandava, / se disnava e se zenava. / Coi Francesi, bona zente, / se disnava solamente. / Co la casa de Lorena, / no’ se disna e no’ se zena. / Co la casa de Savoia / gh’è rivà na fame boia». D’altronde, come dice il proverbio: «Cambiar paron l’è come cambiar molinaro: te cambi ladro».
Cerco la riva dell’Adige. È alto il fiume, e color caffelatte. La sua mano possente porta con sé, insieme alle acque, i detriti degli ultimi giorni di pioggia. Spunto dal folto del fogliame sull’argine e mi affaccio sull’invaso chiuso da due paratie: l’una, con quattro luci, sbarra il corso del fiume, l’altra, con sei, devia la sua acqua nel canale in cui quassù, tra Ala e Avio, l’Adige si biforca. Cerco di immaginare il “pennello deviatore” costruito con cassoni pneumatici che divideva in due le acque. Era il 1929 e i lavori del Canale Biffis erano appena iniziati.Cammino nelle prime luci del giorno. Percorro la valle e constato quanto l’abbiamo scavata, segnata, manomessa. Strade e autostrade, ferrovie e canali rigano questo lembo di terra tra le montagne, si fanno largo tra i paesi e le contrade, tra i campi e le zone industriali. E L’Adige sembra dover cercare la sua via facendosi largo tra gli ostacoli postigli dall’Uomo. Eppure, novant’anni fa, riuscirono a prelevarne una lama d’acqua e a condurla, per 47 chilometri, dalla Bassa Vallagarina fino alle porte di Verona, in un canale che porta il nome di chi lo progettò, a inizio Novecento, Fernando Biffis, l’ingegnere che convinse le istituzioni a costruire un’opera che avrebbe permesso di irrigare i campi e di produrre elettricità. Gli abitanti dapprima osteggiarono l’apertura del mastodontico cantiere della SIME, la Società Idroelettrica del Medio Adige, che avrebbe potuto sconvolgere i ritmi e la vita della valle. Per placare le proteste si dovette arrivare, nel 1928, a un telegramma di Mussolini che intervenne di persona per «troncare ogni altro indugio e iniziare i lavori. Stop».Cerco, ad Avio, il centro sportivo dove un tempo vi era un campo di internamento per prigionieri di guerra. Erano croati, inglesi ma anche balcanici e russi. Lavoravano nel cantiere del Biffis insieme con gli operai del posto. I lavori, interrotti subito dopo l’avvio a causa della crisi economica del Ventinove, ripresero proprio allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale e alla costruzione del canale lavorarono così anche i prigionieri di guerra. Me li immagino nel fondo del grande fossato, armati non di fucili ma di picconi e badili, insieme con i valligiani che ogni giorno si presentavano all’alba sul cantiere. L’assunzione era facile: si arrivava in bicicletta, portando con sé gli attrezzi da lavoro e la gamella con il rancio appesa al manubrio, si accettavano dal capocantiere le condizioni di lavoro e si iniziava a scavare. Nel 1941 la paga variava tra le 1,15 e le 4,20 lire l’ora.La costruzione del Biffis cambiò il rapporto dei paesi con la valle. A Belluno Veronese il canale oggi abbraccia il paese e lo chiude sulla sua riva destra, con cinque ponti a scavalcarlo. Oltre agli uomini penso agli animali selvatici: come avranno attraversato questa barriera d’acqua? A Brentino cerco la Madonna della Corona. Eccola, lassù, a proteggere con la sua mano l’industriarsi degli uomini nella vallata. Gli operai del Biffis, quando la fede consolava la fatica del lavoro, giunti sul cantiere, alla vista della Corona si saranno levati il cappello e, con il Segno della Croce, avranno recitato un’Ave Maria. Poi il lavoro: sei milioni di metri cubi di scavi all’aperto e 650.000 in galleria, guadagnati a metro a metro con il sudore, non uscendo da quei buchi polverosi e bui nemmeno per il pranzo.Ecco, a Preabocco, prima della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, che il Biffis si infila sottoterra. Dovrà oltrepassare la Chiusa di Ceraino, mantenendo la sua pendenza di appena 0,26 per mille, implacabile, inarrestabile, fino a scaricare le sue acque nelle tubature delle centrali idroelettriche a valle.Il Forte di San Marco, bastione a strapiombo sulla valle che pare inaccessibile, annuncia la terra del conteso confine. Prima gli Austriaci e poi gli Italiani costruirono forti qui, dove la valle si restringe, a Ceraino. Incurante delle mura costruite dagli uomini, l’acqua del Biffis percorre il buio del sottosuolo, rompe le rocce su cui posa il Forte Wohlgemuth di Rivoli, inganna questi confini che fecero combattere Napoleone e tutti gli altri come lui.Al suo riemergere di là della Chiusa di Ceraino, il canale non ha più ostacoli, ora è libero di correre verso la pianura. Alla Sega di Cavaion prende perfino il volo. Per fargli scavalcare la valle del Torrente Tasso, tra il 1941 e il 1943 costruirono un ponte di arconi e piloni di calcestruzzo armato a sostenere l’acqua del canale. Sotto l’impressionante arcata passava la vecchia linea ferroviaria Caprino Verona, dismessa nel 1959. Nelle foto pubblicate da Claudio Malini nel suo splendido libro sul Canale Biffis, si può vedere la vecchia locomotiva transitare accanto alle impalcature di legno del cantiere, tra lo sguardo degli operai che la chiamavano La Bigiona.A Piovezzano la grande scarpata in riva al fiume, rivestita di pietre moreniche, è decorata con motivi geometrici: è un’opera di ingegneria e un’opera d’arte. Su questi terrapieni si assiepavano gli abitanti del luogo che venivano ad ammirare, come in uno spettacolo, l’abilità degli scariolanti. Si organizzavano perfino gite domenicali, con tanto di merenda, per andare a vedere il cantiere del Biffis. La gente del posto, i tecnici specializzati e gli operai locali o stranieri, fraternizzavano con i prigionieri di un altro campo di internamento, il 148. Lo cerco, a Pol, ma non c’è più traccia delle baracche in cui prigionieri e militari vivevano, in condizioni misere, durante la guerra, gli uni e gli altri impiegati sul cantiere di quel canale, a pochi chilometri ormai dal suo primo sbarramento: la centrale idroelettrica di Bussolengo.Un salto di soli 8,30 metri basta alle acque del Biffis per far girare le turbine della centrale. Un altro, quello di una seconda centrale, si trova a Chievo. Gli sta di fronte una lapide che ricorda un uomo che cercò con la pittura e la scultura di rappresentare visivamente la velocità: Umberto Boccioni. Chi sapeva che questo campione del Futurismo, caduto da un cavallo imbizzarrito, avesse trovato la morte qui, dove oggi corrono un canale, una strada e una linea ferroviaria? Tutto è movimento, come il gesto creatore di Dio, l’azione che diede vita ad ogni cosa, come l’azione dell’Uomo quando, anziché costruire bombe, costruisce canali per regimentare le acque e vivere in armonia con la Natura.Ecco che il Biffis trova pace nell’Adige e poco oltre ecco un’altra diga, a Chievo, e un altro canale, il Camuzzoni. Opere che portano nomi di uomini di pace.
«Lago da l’aqua fresca o celestina / de le fontane che te sbrissia dentro, / lago de Garda da la recia fina / che te senti tremar le vele al vento / e i limonari quando i se inchina / zo da le rive a farte complimento, / l’èto vista scapar quela regina / che i aveva impresonado a tradimento?» Canto i versi di Berto Barbarani e guardo la Rocca, nell’alba sul Garda. Il limnonimo che si impose sull’antico Benàco ha origine qui, dal posto di guardia (Warda in germanico) che si trovava sulla Rocca.Dorme ancora il lungolago. I pescatori approdano al porto di Garda a scaricare il pescato, i camerieri aprono gli ombrelloni e spazzano le foglie d’autunno, tra poco il popolo dei turisti si sveglierà e sarà la consueta, festosa, eppure caotica e invadente ressa. È l’ora dove godere di uno scampolo di pace. Anche i gabbiani, le anatre, i cigni sembrano godersi il primo tepore del giorno e il silenzio che tra un po’ sarà travolto dai rumori del turismo.Salgo alla Rocca di Garda alla ricerca della fortezza dove avevano «impresonado a tradimento» la regina. Si chiamava Adelaide. Alla fine del Decimo Secolo le avevano fatto sposare Lotario I re d’Italia. Rimase vedova quando il fratello del re, Berengario II, lo avvelenò per usurpargli il trono e pretese che la regina si unisse a suo figlio primogenito, Adalberto. Al suo rifiuto, la moglie di Berengario, Willa, la rinchiuse prima nella fortezza di Lernia sul Lago di Como e poi quassù, nella fortezza sulla Rocca di Garda.Il promontorio che si sporge sul Lago è l’ultima propaggine del Monte Baldo che sembra volersi bagnare i piedi nell’acqua del Garda. La Rocca segna il confine tra i Comuni di Garda e Bardolino, tra l’alto lago montano e tranquillo e il basso e vivace lago collinare. Quassù doveva torreggiare la fortezza costruita nel Quinto Secolo, l’inespugnabile castello dove Turisendo dei Turisendi nel 1162 resistette un anno all’assedio di Federico I Hohenstaufen detto Barbarossa, il maniero che l’imperatore Enrico VI vendette per settecento marche d’argento al Comune di Verona e che nel 1209 Ottone IV demolì, forse per vendicare l’antica progenitrice, Adelaide di Borgogna. Rinchiusa nella Rocca del Garda, alla regina vennero ridotte le razioni di cibo. Prigioniera, Adelaide visse confortata solo dalla compagnia di una serva e di un frate, il monaco Martino. Fu egli a permetterle di fuggire, scavando a colpi di scalpello un cunicolo che conduceva in un luogo appartato della collina.I Gardesani lo chiamano el cesiol o la grotta di Adelaide. Mi chiedo dove sarà, nel segreto della Rocca. Le gallerie militari in cui mi infilo si aprono a una vista sul meraviglioso basso lago, ma la parete strapiomba: è impossibile scendere di qui. Mi rassegno, la Rocca custodisce il segreto del cesiol. Scendo a Garda per il sentiero dove ora salgono correndo i salutisti del jogging. Sulla riva del lago non c’è più pace, l’andirivieni dei turisti fagocita ogni cosa. Le voci coprono le grida dei gabbiani, i rombo dei motori lo sciabordio delle onde.Adelaide ricevette aiuto da un pescatore che la imbarcò sulla sua piccola barca e, nottetempo, le fece attraversare il lago, inseguita da Berengario e i suoi scagnozzi. Un vento sotterraneo e misterioso si levò dalle acque sospinse Adelaide verso la salvezza, mentre i suoi inseguitori vennero avvolti dalla nebbia. Quel vento, racconta la leggenda, da quel giorno si alza ogni sera e permette di raggiungere in una notte tutti i luoghi del Garda. Non è l’Ora, alito che soffia da sud, da mezzogiorno a sera, non è l’impetuoso Pelér che pela il Lago da Nord, avanzando come un leone, non è l’Andèr, vento che se soffia dal bresciano nel primo pomeriggio annuncia bel tempo ma se soffia fuori orario porta tempesta perché l’Andèr l’è balander, non è nemmeno il Balì, il vento del tempo bello, fresco e asciutto che viene e va in tre giorni, né la Vinèsa, vento impetuoso che soffia a raffiche dal basso lago e porta tempesta, né la Visentina che l’è ladra o assassina, non è nemmeno il Ponàl che, come dice un altro proverbio, no’l porta altro che mal. Il vento che spinse lievemente la barca di Adelaide verso Sirmione non ha nome. Per riconoscerlo bisogna navigare di notte, in solitudine, e lasciarsi portare dalle onde e dalla fantasia.«Ecco, la verde Sirmio nel lucido lago sorride, / fiore de le penisole», cantò Giosuè Carducci. Sbarcata sulla penisola, Adelaide raggiunse e attraversò agevolmente la Selva Lugana, io a fatica mi muovo nella selva di caffè e gelaterie tra una folla imbizzarrita. Lei, la regina, si districò in fretta tra la boscaglia e raggiunse lo Stagno del Lavagnone, a Desenzano, o forse l’antico monastero di Lonato, o addirittura la fortificata Peschiera. Sia come sia, Adelaide arrivò fino alla Reggia dei Canossa, sull’Appennino Reggiano. Qui chiese protezione a Ottone il Grande, re di Germania, che se la sposò. I due vennero incoronati imperatori del Sacro Romano Impero nel 962. Morto Ottone I, Adelaide divenne consigliera del figlio Ottone II e tutrice del nipote Ottone III. Si prodigò nella diplomazia, fondò conventi e aiutò monasteri, si guadagnò la fama di grande cristiana e cento anni dopo la morte, accorsa presso l’abbazia di Selz in Alsazia nel 999, Urbano II la elevò agli altari e da allora è venerata come Santa Adelaide di Borgogna.Ma se, come assicura la leggenda, non se ne fosse mai andata dal Lago di Garda? Se proprio qui, a Sirmione, avesse un segreto amante? Sulla punta estrema della penisola l’accesso alle Grotte di Catullo è chiuso. Cerco queste rovine tra la boscaglia che le circonda e mi pare così di vederle come dovevano averle viste i viaggiatori quattrocenteschi che confusero queste mura diroccate con delle caverne. Qui aveva una villa Gaio Valerio Catullo, il poeta romano che cantò Sirmione nel suo Carme XXXI: «Sirmione, perla delle penisole e delle isole…». A credere alla leggenda (e ci si deve credere fermamente) Adelaide e Catullo erano amanti e si incontravano in segreto tra queste mura, anche se Catullo era vissuto mille anni prima di lei.«Da ti, Garda, el Lago el spina / le memorie vecie e intate… / L’era tuta quela regina, / ch’è scapà vestì da frate / col rosario atorno al col…», canta ancora Berto Barbarani. Quanti poeti hanno eternato il Garda nei loro versi. Quanto amore per questo catino d’acqua circondato dalle montagne, per le sue rive coronate da limoni, cipressi e olivi, per la carezza delle sue brezze e l’impeto dei suoi venti, per le storie che ha visto passare, per le fiabe che ha sentito raccontare. «El vento supia, dal Monte Lupia. Canta, canta, barcarol!»
Aveva preso in affitto una misera stanza in Via San Salvatore Corte Regia Francesco Cevolini, mercenario al soldo dei Lanzichenecchi, dopo aver rubato, così raccontano le antiche cronache, un fagotto di stracci agli Alemanni. Stracci infetti, evidentemente. Sulle rive dell’Adige lo ospitava tale Lucrezia Isolani. Quando, pochi giorni dopo, lo trovarono morto nel suo letto, il mercenario aveva già contagiato Lucrezia e la sua figliola, Margherita. Era il 15 marzo 1630 e la peste entrava a Verona. Brilla l’Adige ai primi raggi del sole che sorge dietro al campanile di San Tomaso Becket. Lo guardo percorrendo il Lungadige Rubele e immagino i barconi colmi di appestati, con i barcaioli a debita distanza, a proteggersi con uno straccio la bocca per evitare il contagio. Sulla pala d’altare che nel 1636 il Comune commissionò ad Antonio Giarola, custodita nella basilica di San Fermo Maggiore, si vedono galleggiare i cadaveri lungo l’Adige, mentre una donna vestita di giallo e blu, a simboleggiare Verona, con il Leone Marciano affranto ai suoi piedi, invoca Maria che trattenga Cristo dallo scagliare le frecce scarlatte della punizione divina sulla città. «Il male invisibile», lo definì lo storico Carlo Maria Cipolla. «Il gran castigo di Dio», da cui era inutile tentare di sottrarsi. Quella che nel 1630 colpì l’Italia Settentrionale, provocando più di un milione di morti, fu una peste bubbonica, la stessa raccontata da Manzoni ne I promessi sposi. A Verona morirono più di trentamila persone su una popolazione di cinquantamila abitanti. Entrando nel Quartiere Filippini penso a cosa doveva aver visto, in quei giorni, il medico Francesco Pona quando scrisse le sue cronache nel libro Il Gran Contagio di Verona: «I cenci più sordidi, le più rozze, lacere, e rifiutate vestimenta, i più schiffi, e squarciati letti, et i più succidi origlieri si vedeano innanzi alle case, semiusti, e tra cieche et orride fiamme ammorbar di fetente fumo le contrade intiere...».Anche Lucrezia, portando in grembo la piccola Margherita, guardava quelle scene miserevoli mentre percorreva la strada per arrivare alla Chiesa del Cristo. Oggi non è rimasta che una targa a indicare la chiesa in cui, sul luogo dove con una lisca di pesce vennero decapitati i santi Fermo e Rustico, v’era il crocifisso miracoloso che gli appestati e i lebbrosi invocavano prima di essere imbarcati sull’Adige per il pietoso viaggio verso il Lazzaretto.L’idea di costruire un nuovo lazzaretto (o nazzaretto) propinquo al fiume Adige venne presa dal Consiglio dei Dodici e dei Cinquanta il 7 gennaio 1539. Fino ad allora, in caso di pestilenze i contagiati venivano rinchiusi nei casotti di legno di San Zeno e di Campo Marzio, altri nell’Ospedale di Sant’Agnese in Piazza Bra o nella Domus Pietatis in Piazza Dante, altri ancora nel vecchio Ospedale dei Santi Giacomo e Lazzaro, nel quartiere di San Pancrazio, detto «San Giacomo alla Rogna». Quando, nel 1517, i Veneziani realizzarono la così detta Spianà, abbattendo tutte le abitazioni e le piante ad alto fusto nel perimetro di un miglio intorno alla città, anche l’ospedale venne demolito e ricostruito nel quartiere di Borgo Roma e da allora si chiamò “San Giacomo alla Tomba”.La nuova struttura ospedaliera era stata terminata pochi decenni prima. Dal 1539, infatti, passarono otto anni prima che i tre incaricati del comune che dovevano scegliere il luogo dove costruire il Lazzaretto riferissero ai Consigli d’avere individuato all’interno dell’ansa dell’Adige un posto adatto, lontano dalle abitazioni nobiliari, raggiunto dal fiume che avrebbe permesso il trasporto degli ammalati senza il rischio che contagiassero altri cittadini. È probabile che il progetto di questo immenso ospedale, il più grande lazzaretto d’Italia dopo quello di Milano, fosse stato affidato fin da subito a Michele Sanmicheli che già stava lavorando in città. Vasari, nelle sue Vite, afferma che il progetto approvato dai rettori era stato ridimensionato dall’amministrazione cittadina. Non è dato sapere se l’ospedale terminato nel 1603, e costato più di ottantamila ducati, fosse quello progettato dal grande architetto veronese. A un approdo sul fiume, oggi invisibile tra il fitto della vegetazione, sbarcavano gli ammalati.Da lì una stradina conduceva fino alle mura del Lazzaretto. La cerco tra le sterpi e, districandomi tra i rovi, intravedo ciò che resta delle mura di cinta dell’ingresso occidentale. Penso a Dante e a quell’iscrizione perentoria sulla porta dell’Inferno: «Lasciate ogne speranza voi ch’intrate». Penso a Lucrezia e a sua figlia che, come tutti contumaciati che dovevano trascorrere in questo luogo dai 7 ai 40 giorni di quarantena, si dovettero spogliare delle loro povere vesti e raggiungere una piccola cella, tra le 152 che si aprivano sul chiostro di 239 per 117 metri che circondava lo spazio centrale, suddiviso da quattro mura oblique in quattro zone isolate tra di loro, denominate Adige, Caneva, Verona e Pomellara. Anche i mercanti che, scesi da Bolzano o da altre zone sospette, giungevano a Verona erano sottoposti a quarantena preventiva. Le loro merci, come tutta la posta che entrava e usciva dal Lazzaretto, venivano disinfettate tramite fumigazione: con dello zolfo in polvere si bruciavano sostanze aromatiche, sterpaglie, paglia o legni odorosi. Chiamavano quell’operazione «il profumo».Mi chino, raccolgo e annuso le erbe aromatiche che gli Amici del Lazzaretto hanno piantato nel perimetro delle celle. Alzo gli occhi e vedo, nel brillare del sole, il tempietto. Da ciascuna di queste celle gli ammalati potevano vedere, tra i suoi due ordini di colonne tuscaniche, l’altare dove il sacerdote innalzava l’ostia consacrata al cielo a rinfocolare, nella preghiera, la speranza. Oggi non c’è più la cupola rivestita di piombo che proteggeva l’interno del tempio, crollata per l’incuria del tempo e infine devastata dall’esplosione che distrusse il Lazzaretto nel 1945, quando da più di un secolo era diventato un deposto d’armi. Un cielo azzurro si apre ora sopra quell’anello di luce disegnato dal Sanmicheli. Quanti giorni trascorsero Lucrezia e Margherita nel Lazzaretto? E cosa restò nel ricordo della bambina di quando vide chiudersi gli occhi di sua madre? Chi si occupò di lei che, sopravvissuta alla peste, poté infine uscire da quel quadrilatero di dolore? In loro memoria, e dei tanti senza nome che qui vissero, soffrirono e sperarono, gli Amici del Lazzaretto oggi custodiscono questo spazio, nell’abbraccio dell’Adige.
l Santo camminava tra i prati e le contrade, lui su un cavallo bianco, il suo segretario su un cavallo nero. Il Papa lo aveva inviato a Trento dove, nella grande basilica, vescovi e cardinali non riuscivano a portare a termine il Concilio. Tra di loro, vestito da frate, vi era il diavolo che con le sue parole ingannatrici seminava la discordia. L’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo era già in odore di santità. Ecco che il Santo Padre era certo che recandosi a Trento avrebbe sconfitto Lutero e i suoi seguaci che predicavano che «el papa no’ l’era el Cristo in tera» e avrebbe portato a termine il Concilio. La chiesetta dedicata a San Carlo Borromeo, a Camposilvano, lungo l’antica strada che conduce ai pascoli alti della Lessinia, è un indizio del passaggio dell’Arcivescovo. Ma perché a Camposilvano? E perché salire sulle montagne della Lessinia per arrivare a Trento?Vi erano i briganti ad aspettarlo alla Chiusa di Ceraino e fu uno di loro, fedele al papa, ad andare incontro a San Carlo e ad avvertirlo del pericolo. Così l’Arcivescovo decise di salire sulle Sine (i Lessini), percorrere il Vaio di Squaranto e la Strada Cavallara arrivando proprio a Camposilvano. Chiesta ospitalità per la notte, a sera San Carlo si sentì raccontare dalla gente del posto le storie delle fade, esseri malefici che rapivano i bambini incustoditi, strangolavano le donne con fazzoletti di seta e tenevano prigionieri i montanari. Immagino, davanti alla chiesetta, il santo seduto su uno scranno, con intorno un capannello di persone. Mi chiedo se la gente di Camposilvano gli parlasse in tauc, l’antico dialetto alto-tedesco, il così detto cimbro, e come fossero riusciti quei contadini e boscaioli a spiegare a San Carlo che le fade un tempo erano solidali con gli uomini, avevano insegnato loro il segreto per fare il formaggio con il caglio e regalavano alle donne gomitoli di lana che non finivano mai.Fu a causa della curiosità e la malizia di alcuni giovanotti che diventarono ostili. Aspettatele fuori della stalla dove partecipavano al filò, vennero loro strappati di dosso i meravigliosi abiti per vederne il corpo e scoprire così che le bellissime ragazze arano pelose, con vipere vive al posto delle cinture e le zampe come quelle di una capra. Ecco che, da allora, si vendicarono con i montanari tormentandogli in ogni modo. I massi del Vaio delle Buse sono dipinti di giallo dal primo sole d’autunno. Tra queste pietre friabili, che qualcuno chiama sfingi, gli orchi andavano a spiare le fade mentre, nude, si lavavano nella pozza d’acqua. Cerco lo spioncino da dove gli orchi le guardavano segretamente ma non lo trovo. Da qui, dove avevano la loro dimora, le fade vennero poi scacciate proprio da San Carlo Borromeo quando, arrivato a Trento, scagliò la sua maledizione contro di loro e le costrinse a vivere nel Cóvolo di Camposilvano, la grande caverna che perfino Dante visitò, trovandone ispirazione per il suo Inferno.Quante volte sono sceso nel Cóvolo? E quante storie ho cercato qui, protetto da questa immensa corona di roccia che strapiomba nel buio del sottosuolo? Ricordo Attilio Benetti, indimenticabile ispiratore, consigliere e amico, quando raccontandomi la storia di Calamita mi indicava la fessura nella parete di roccia dov’ella, che aveva il dono di potersi trasformare in essere incorporeo, poteva passare per entrare nella sua sontuosa dimora. Un tempo era costei ella stessa una fada ma per i suoi meriti (aveva insegnato ai montanari a fare la ricotta) fu trasformata da San Carlo in una donna bellissima che non invecchiava mai. La sua abitazione era scavata nella roccia, nell’antro più segreto del Cóvolo, le pareti delle stanze erano rivestite di cristalli, sulla cappa del camino vi era appeso uno schioppo con il calcio di lamine d’oro e su uno scaffale di legno stava in bella mostra il Libro del Diavolo. Calamita possedeva, infine, una vecchia pignatta nera che si riempiva di ogni cosa desiderata soltanto sfiorandola con due dita e recitando le parole magiche.Ma, pur avendo tutto ciò che desiderava, Calamita era sola. Così decise di sposarsi con un montanaro che le fosse piaciuto. Si vestì riccamente, con una abito di seda del Trentin e uno scialle ricamato d’oro, grazie ai suoi poteri uscì dalla stretta fessura nella roccia e raggiunse un crocevia.Cammino verso la Valsguerza. Penso alla cava di marmo giallo reale che l’avrebbe devastata e avrebbe distrutto l’antica carrareccia se, ventitré anni fa, in migliaia non avessimo camminato in silenzio per salvarla. Al crocevia della Crose del Galo immagino Calamita aspettare che passasse di lì qualcuno che le piacesse. Passò un giovane e vedendo una donna così bella, di notte, fuggì a gambe levate per andare a rifugiarsi in una stalla e raccontare, pallido per lo spavento, d’aver incontrato un’anima purgante venuta a intercedere per i suoi peccati. Calamita pensò d’averlo spaventato a causa dei suoi abiti preziosi, tornò dunque al Cóvolo e si vestì poveramente, come una montanara. Tornò al crocevia e un altro giovane passò e anche lui, quando la vide, fuggì. Allorché, rassegnata, si riavviò verso casa, un mercante tirolese che stava andando a vendere la sua seta al mercato di Badia la vide, si fermò per chiederle la strada e, per nulla spaventato, si lasciò convincere a seguirla nella sua dimora, il Cóvolo.Tra gli enormi massi di rosso ammonitico, scendo lungo la frana scoscesa che un tempo era il soffitto di questa caverna. Giunto dove la grande bocca nera si apre, a inghiottire le felci, guardo verso la fessura a «V» che Attilio mi indicava, assicurandomi che era l’ingresso della dimora di Calamita. Giunta fin qui, la donna disse al mercante che se avesse venduto l’anima al diavolo sarebbe entrato potuto entrare nella sua casa, avrebbe avuto tutto ciò che desiderava e avrebbe fatto per sempre l’amore con lei. Quando il giovane titubò, lei lo convinse con il suo fascino femminile, poi andò a prendere il Libro del diavolo, lesse qualche parola scritta in rosso ed ecco due diavoli accorsero, alzarono un grande masso di pietra come fosse una piuma così che Calamita e il mercante potessero sparire nel buio.Quante volte, perfino di notte, sono restato in silenzio a udire la voce disperata di quel giovane mercante? Nella fastosa dimora di Calamita egli aveva ogni cosa poteva desiderare e poteva fare l’amore con lei, ma gli mancava la cosa più preziosa: la libertà. Così, dal profondo del Cóvolo, ancora oggi si possono udire, mescolate con il sibilo del vento, le sue grida disperate: «Sono dannato… Ho venduto l’anima al diavolo…».
Salivano di notte da Ala per l’impervio sentiero della Valbona fin sui pascoli alti della Lessinia i contrabbandieri, per sfuggire alle guardie del confine tra il Regno Lombardo Veneto e l'Impero Austroungarico. Dopo il 1866, per procurarsi a un prezzo ragionevole zucchero, caffè, tabacco, sale, pepe e spirito, i montanari diventarono fuorilegge per fame e miseria. Tra di loro si racconta di Toni Sberla e di come riuscì a mettere l’uno di fronte all’altro un contrabbandiere e un finanziere e far capire a entrambi d’essere solo due pori cani. Alessandro Anderloni racconta e cammina la sua storia.
Aveva la sua tana sulle cenge a strapiombo sull’alta Valpantena. Era un uomo dalla fama obbrobriosa, crudele e spietato. Nel 1675, su mandato dei conti Giusti di Santa Maria in Stelle, rapì la bella Angiolina Leonardi. Prestava i suoi servigi come bravo per i signorotti della valle, tra cui il potente Conte Alegro che aveva la sua villa a Cuzzano, meschino e spregiudicato non meno dei suoi buli. Alessandro Anderloni cammina la storia del Brigante Falasco, da Poiano alla sua torre sopra Grezzana.
A metà del Trecento, gli Scaligeri costruirono un’imponente muraglia che collegava Borghetto, il castello di Valeggio e quello di Villafranca e che doveva arrivare fino alla Rocca di Nogarole. Un bastione difensivo di centocinquanta torri, lungo il corso del Tione dei Monti e delle Valli, a prolungare le difese naturali del Garda, del Mincio e delle paludi di Grazzano. Alessandro Anderloni cammina sulle tracce delle antiche e scomparse mura del Serraglio Scaligero.
È stato definito il Santuario più ardito d’Italia. Qui, secondo leggenda, nella notte del 24 giugno 1522 apparve, in una nicchia nella roccia a strapiombo sulla Val d’Adige, la statua dell’Addolorata scomparsa lo stesso giorno dall’isola di Rodi. Alessandro Anderloni percorre la via dei pellegrini che scendono dal Corno d’Aquilino e risalgono i 1672 scalini che da Brentino portano lassù, al Santuario appeso alla roccia.
Alessandro Anderloni cammina la Verona di Dante, la città che fu per il poeta rifugio e ostello cortese. Da Piazza Dante, attraversando i luoghi legati alla presenza veronese dell’esule fiorentino, in una giornata di primavera, a scoprire la meraviglia della nostra città e a contraccambiare la riconoscenza che le dedicò il poeta nel XVII canto del Paradiso.
Nell’anno del Signore 806, costruita a Verona la grande Basilica di San Zeno, per traslare nella cripta la salma del patrono della città scesero dalle pendici del Monte Baldo, dove avevano scelto di vivere in eremitaggio, Benigno e Caro. Da Cassone, sul Lago di Garda, Alessandro Anderloni ha camminato fino al loro eremo, in una giornata di nebbia, pioggia e poesia.
Le Grandi Valli Veronesi un tempo erano una città di cento torri, circondata da sette ordini di mura. In un grande lago alle sue spalle confluiva l’acqua di fiumi e canali, regolata da dighe, chiaviche e paratie. La sfrontatezza di un re e l’avidità dei sacerdoti del tempio al dio Appo furono la rovina della mitica Atlantide delle Basse. Alessandro Anderloni cammina e racconta, tra terra e acqua, l’antica leggenda di Carpanea.
Àissa Màissa, il montanaro e l’orco buono. Amore e morte nella Valle dei Cóvoli. Di e con Alessandro Anderloni.