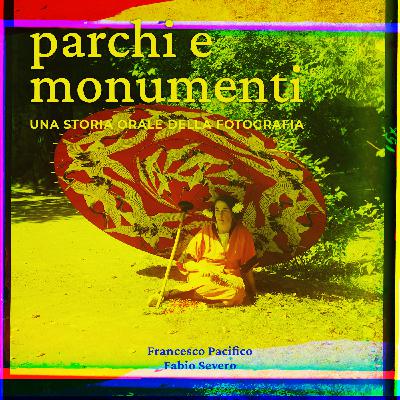Discover parchi e monumenti
parchi e monumenti

 parchi e monumenti
parchi e monumenti
Author: Haruomi Podcast
Subscribed: 6Played: 13Subscribe
Share
© Copyright Haruomi Podcast
Description
Parchi e monumenti: una storia orale della fotografia. Un podcast per imparare la fotografia senza le semplificazioni della divulgazione scientifica. Fabio Severo, critico fotografico e scrittore, spiega la fotografia a Francesco Pacifico, scrittore e fondatore del Tascabile Treccani. Un podcast notturno sull'arte della luce.
18 Episodes
Reverse
Due fotografie dei primi anni del '900: migranti pronti a sbarcare a New York. Una entra nel patrimonio della grande fotografia documentaria socialmente impegnata; l'altra è considerata l'atto di nascita del modernismo fotografico. Come è possibile che due fotografie tanto vicine partano verso direzioni così distanti tra loro? Dove si collocano tra i due estremi del linguaggio fotografico, tra documentazione e finzione? E poi, esiste una terza via per evitare l'obbligo di scegliere tra l'una e l'altra? Con il saggio di Allan Sekula "On the Invention of Photographic Meaning" (1975) entriamo in una delle questioni più affascinanti del gioco tra rappresentazione e verità sollevate dalla fotografia. (Ma la cit. del titolo è di un comico, Fred Armisen, che spiega come mai è stufo degli stilemi della fotografia.)
"L'idea che mi sono fatto viaggiando è che nessuno sa come vanno le cose davvero, la realtà sociopolitica delle città e delle loro comunità è alimentata soltanto da apatia e istinto di conservazione.""Penso che voler essere nel giusto sia una forma di pregiudizio. Non sto cercando di provare nulla e sono troppo misantropo per voler modificare la percezione che la gente ha del mondo."Queste e altre massime nere fanno il pensiero di Philip-Lorca diCorcia, autore di una street photography capovolta, dove all'urgenza dell'istantanea si sostituisce l'immobilità del quadro. In diCorcia si incontrano la vita di strada e la messa in scena sofisticata, Nan Goldin e Jeff Wall, lo squallido e la sofisticazione. Miscelazioni complesse e rischiose con cui scendiamo sempre più a fondo nel rabbit hole dello stile falsario, dove i flash nascosti agli angoli delle strade scattano come trappole per catturare il fantasma della vita interiore.
Fotografie come still da film in bianco e nero, bambole mostruose, dipinti classici trasformati in scene grottesche. Gli autoritratti recitati di Cindy Sherman prendono l'immaginario popolare e lo tramutano in un teatro di inquietudine, dove il corpo dell'artista viene usato per rappresentare un catalogo infinito di immagini femminili tra identità, cliché e ruoli sociali. Impossibile non innamorarsi di lei, della sua libertà, del suo rapporto libero e leale con la forma. Visto che fin qui abbiamo celebrato Jeff Wall, ora mettiamo Wall e Sherman uno di fronte all'altra e vediamo se davanti alla mutaforma il ragazzo new wave si spettina un po'.
Negli anni '70 in America l'arte fotografica prende di mira lo stile documentario, cominciando a considerare illusoria l'idea di unire la bellezza della forma all'impegno sociale. La resistenza al modernismo in fotografia porta un gruppo di artisti a prendere ispirazione dal mondo dei mass media, della pubblicità e delle immagini vernacolari. La fotografia smette di documentare e introduce nuove parole d'ordine: citazione, appropriazione, decontestualizzazione. Nei lavori di Sherrie Levine, Martha Rosler o Allan Sekula la sapienza manuale dell'artista perde significato, lasciando il posto a teorie critiche in forma di immagini. Nel frattempo, Jeff Wall non rinuncia al tableau classico e chiede aiuto al più grande pittore della vita moderna, Édouard Manet.
Comincia la seconda stagione di Parchi e monumenti, ripensando a tutte le cose viste e dette sullo stile documentario in fotografia, e chiedendoci se non sia il momento di parlare dell'esistenza di uno stile falsario: doppio bizzarro, uguale ma opposto al suo illustre precedente. Parlando di messa in scena e dichiarato artificio in fotografia non si può che cominciare con Jeff Wall, maestro della staged photography e creatore di tableau in cui lo stile documentario e la finzione si incontrano per rappresentare il teatro della vita contemporanea, fatto di "movimenti meccanici, reazioni automatiche, risposte involontarie e compulsive".
Di cosa abbiamo parlato nel corso delle prime dodici puntate del podcast? Noi abbiamo la sensazione che si sia conclusa la prima stagione della nostra night radio fotografica: siamo partiti dalle nebbie della nascita della fotografia e siamo arrivati agli anni '70 del XX secolo, dove la fotografia sembra divisa tra documento e finzione, tra realtà e immaginazione. E allora proviamo a riassumere questi due mesi e mezzo in un'oretta scarsa, per chi non avesse voglia di ascoltare tutte le puntate.
Concludiamo la lettura di "Too Old to Rock, Too Young to Die", saggio scritto dal fotografo Lewis Baltz nel 1985 dedicato alla fotografia americana negli anni '70, già protagonista della nostra ottava puntata. Pubblicato in Italia da Johan & Levi nella raccolta "Scritti", "Too Old to Rock" è una splendida riflessione su vizi e virtù della fotografia in un decennio in cui sperimentazione, tradizione e conformismo si sono sfiorati tra loro nella grande espansione del mercato dell'arte contemporanea, subito prima del riflusso portato dagli anni '80. (Contiene complimenti alla traduttrice Emilia Sala.)
Mentre veniva pubblicato Uncommon Places di Stephen Shore, un altro fotografo viaggiava attraverso gli Stati Uniti interrogandosi sul senso del paesaggio americano contemporaneo: così, quattro anni dopo il libro di Shore usciva American Prospects (1987) di Joel Sternfeld, che con Shore aveva in comune la visione contemplativa, la fotografia di grande formato e il colore. Ma nel libro di Sternfeld il senso dei luoghi va oltre l'elogio dell'anonimo di Shore: per Sternfeld l'America degli anni '80 è un mondo di contrasti e di incongruenze, e dietro ogni villetta monofamiliare si nasconde una voragine, sopra una domenica in piscina c'è una cappa di nuvole, mentre Ferrari vengono parcheggiate accanto a prati dipinti di rosa.
L'iperrealismo meditativo di Stephen Shore viene esportato in Europa grazie a Bernd e Hilla Becher, che con Shore avevano esposto nella mostra New Topographics. Dalla fine degli anni '70 Bernd Becher insegna fotografia all'Accademia di Belle Arti di Dusseldorf, dove formerà nel corso di un decennio una generazione di artisti fotografi. Andreas Gursky, Thomas Struth e Thomas Ruff trasformeranno la contemplazione dell'America anonima di Shore in una sinfonia apolide del tardocapitalismo, un gigantismo della rappresentazione fotografica destinato a farsi amare da musei e collezionisti.
Tra le suburbie e i trailer park monocromatici di New Topographics risalta il cromatismo delle fotografie di Stephen Shore, unico artista in quella mostra a utilizzare il colore. Quelle sue fotografie esposte nel 1975 andranno a far parte di Uncommon Places, libro pubblicato da Shore nel 1982 che raccoglie il frutto dei suoi viaggi attraverso il Nord America tra il 1973 e il 1979. Habitué della Factory di Andy Warhol alla fine degli anni '60, Shore guarda al paesaggio come deposito di immaginario collettivo, partendo da stanze di motel, diner e pancake & sciroppo d'acero per arrivare a una meditazione per immagini sul volto del presente americano.
"Too Old to Rock, Too Young to Die - La fotografia americana degli anni settanta" è il titolo di un saggio di Lewis Baltz scritto nel 1985 e contenuto nella sua raccolta "Scritti", pubblicata in Italia da Johan & Levi in una splendida edizione a cura di Antonello Frongia. Baltz non è solo uno dei nomi della mostra dei New Topographics, ma anche un fotografo molto bravo a scrivere (ne stiamo scoprendo diversi). Fotografo dell'ordinaria bruttezza del paesaggio capitalista, Baltz nel suo testo guarda indietro alla recente stagione di fioritura della fotografia nel mondo dell'arte contemporanea. Da bravo marxista non si limita a una critica estetica ma guarda all'apparato che sostiene tale fenomeno: la proliferazione di sussidi governativi per le arti, le nuove architetture museali in cerca di opere da esporre, il nascente mercato delle gallerie private. Se la prende con i critici superficiali, gli accademismi obsoleti, ma cerca anche i segni di vita in una fotografia schiacciata tra il pittorialismo del passato e le mode del presente. Dopo il fotografo testimone, il fotografo archivista e il seguace delle belle arti, Baltz ci propone un'altra identità dell'uomo con la camera: il fotografo pensatore.
L'atlante umano di August Sander ha alimentato un ampio spettro di ricerche fotografiche successive: c'è la figura umana e il suo posto in società, dall'antropologia gotica di Diane Arbus agli algidi ritrattisti europei di fine XX secolo, come Rineke Dijkstra e i suoi adolescenti inespressivi, sorta di Sander trapiantato nel postmoderno; e c'è la scoperta del paesaggio come problema, come manifestazione di un presente contradditorio, conflittuale. Scompaiono le vedute di canyon maestosi, di parchi e monumenti: arrivano i parcheggi dei supermercati, i quartieri periferici, i capannoni industriali. Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd e Hilla Becher, Stephen Shore: nuove topografie per fotografare il paesaggio alterato dall'uomo.
Artista rivoluzionaria, manipolatrice, martire della fotografia, icona rock: Diane Arbus è stata definita in ogni modo, intrappolata nell'equazione arte e vita offerta dal suo destino tragico e dai tragici eroi dei suoi ritratti. Arbus ha preso la Nuova Oggettività di August Sander e l'ha capovolta: Sander fotografava i volti del nostro tempo alla luce del sole, lasciando intravedere l'individuo dietro la maschera della vita pubblica; Arbus ci mostra un privato sommerso, notturno, così irriducibile a un ruolo sociale da sembrare quasi osceno.
Scrivendo di presente e futuro della fotografia nel 1931, sia Walter Benjamin che Walker Evans concludono indicando nel lavoro di August Sander la strada da seguire per comprendere lo spirito del tempo e le sue difficili traiettorie. "Il volto del tempo" (1927) è una raccolta di ritratti di cittadini tedeschi di ogni classe sociale, età, professione. "Un atlante su cui esercitarsi", secondo Benjamin; "un esempio di come l'apparecchio fotografico possa guardare nella giusta direzione", aggiunge Evans. "Come esiste un'anatomia comparata", si legge nell'introduzione al libro di Sander, "così questo fotografo ha realizzato una fotografia comparata." Anche Evans, nell'introduzione al suo "American Photographs" del 1938, viene paragonato a un medico: "un diagnostico... un medico di famiglia pacato e obiettivo, davanti al quale anche i vecchi e i malati gravi non hanno più vergogna di mostrarsi." Dai "documenti per artisti" di Eugène Atget alla clinica visiva di Evans e Sander, la fotografia si fa documentazione per interrogare lo stato di salute del presente.
American Photographs è il titolo di una mostra e di un libro del 1938 di Walker Evans. Nonostante il suo amore per la scrittura, qui Evans decide di non aggiungere parole alle sue fotografie, salvo un elenco di didascalie minime riportato alla fine di ognuna delle due parti in cui è diviso il libro. "Marciapiede e vetrina di negozio, New Orleans, 1935", "42esima strada, 1929", "Volti, Pennsylvania Town, 1936". American Photographs è il capolavoro recalcitrante della modernità fotografica, tanto ricco e stratificato quanto reticente a indicare la via, a insegnare. "Ecco i documenti di un'epoca prima del suo imminente collasso", scrive l'amico Lincoln Kirstein nell'unico testo riprodotto alla fine del libro. "Ogni cosa viene osservata frontalmente, con la schiettezza di un'icona russa o di un dipinto fiammingo. I fatti si accumulano insieme alle loro immagini."
"Volevo scrivere così tanto che non riuscivo a scrivere una parola." Uno dei fotografi più grandi della storia, l'americano Walker Evans, voleva fare lo scrittore. Nel 1931 scrive "The Reappearance of Photography", un articolo su alcuni libri usciti negli anni precedenti. Il testo è una sorta di gemello della "Piccola storia della fotografia" scritta da Walter Benjamin nello stesso anno. Anche Evans se la prende col pittorialismo del fotografo di fine Ottocento ("un pittore fallito con la sua scatola di trucchi") e loda le sperimentazioni dell'inizio del nuovo secolo. Come Benjamin, anche Evans scrive di Eugène Atget, fotografo della Parigi tra i due secoli che invece delle grandi architetture e dei viali fotografa le vetrine delle botteghe e i vicoli deserti. Infine, come Benjamin, Evans ama scrivere, da prima ancora di voler fotografare.
Dopo il saggio del '31 in cui Benjamin implorava la fotografia di inventarsi qualcosa di buono, saltiamo al '77 per un secondo reboot. Nel libro di Mandel e Sultan troviamo signori che parlano al microfono, cavi che escono dalle pareti, braccia che escono da muri, camere anecoiche con forme gonfiabili non meglio precisate, un uomo in giacca e cravatta con gli stivali fino al bacino in una specie di fogna, uomini coi caschi da cantiere che stanno in mezzo a della schiuma... Il mondo contemporaneo stava perdendo un'immagine riconoscibile e la fotografia doveva inventarsi forme nuove per darne conto.
Comincia il corso di fotografia nella confusione più assoluta. Quando è nata la fotografia? Nella prima metà dell'Ottocento si spedivano i fotografi a fotografare il patrimonio naturale e quello storico. Arrivati agli anni Trenta del Novecento Benjamin è insoddisfatto di quest'arte che ancora non sa dove andare a parare.