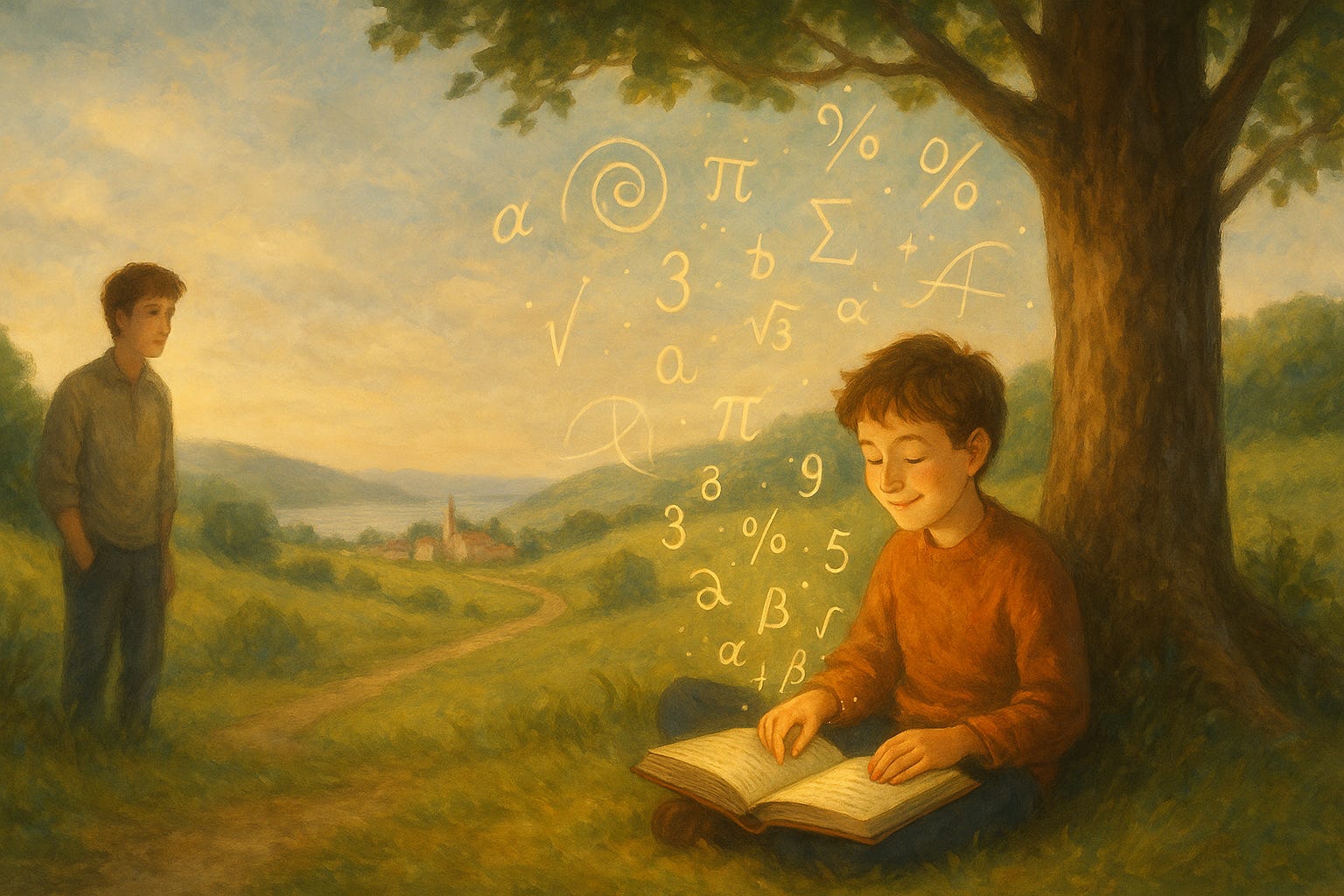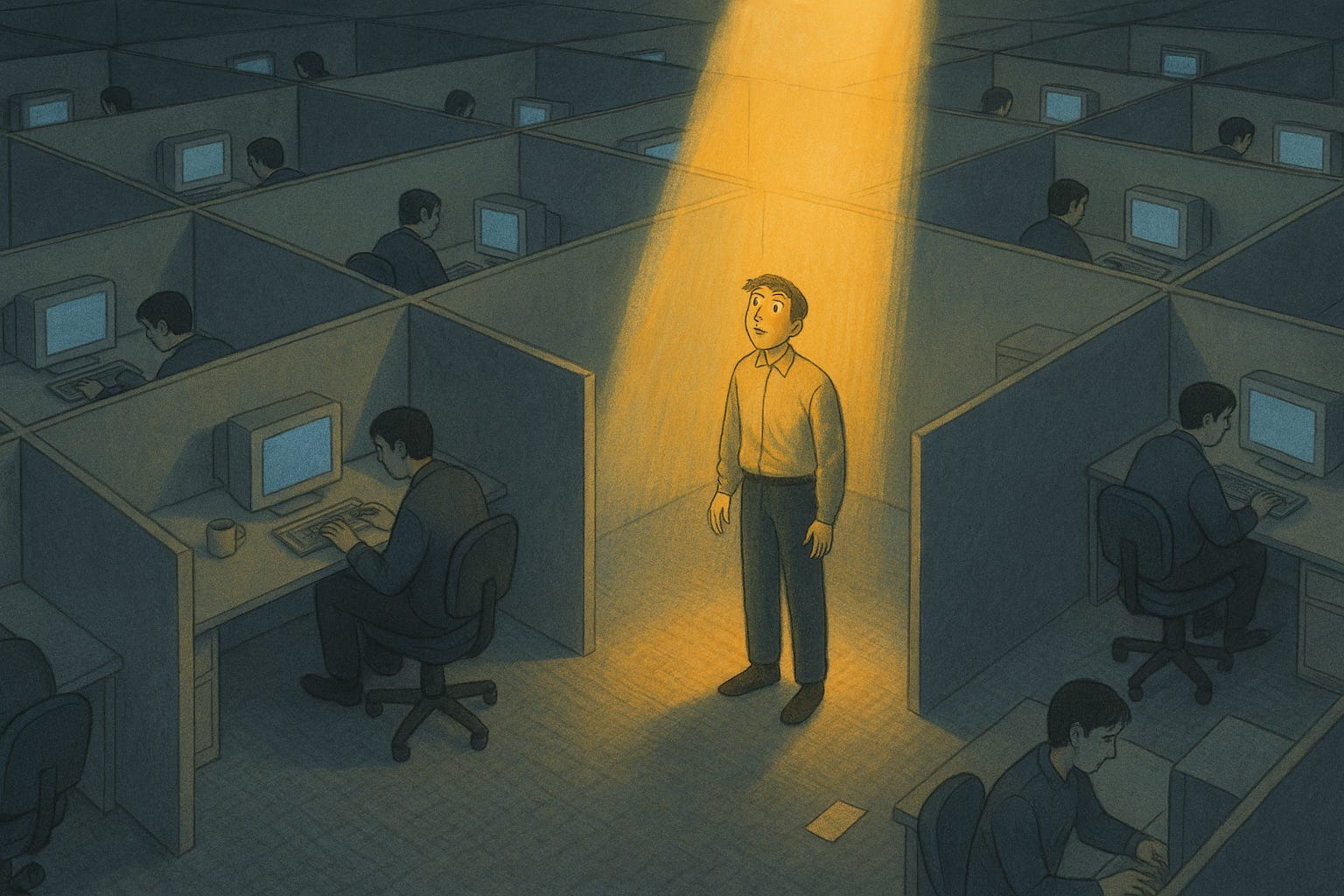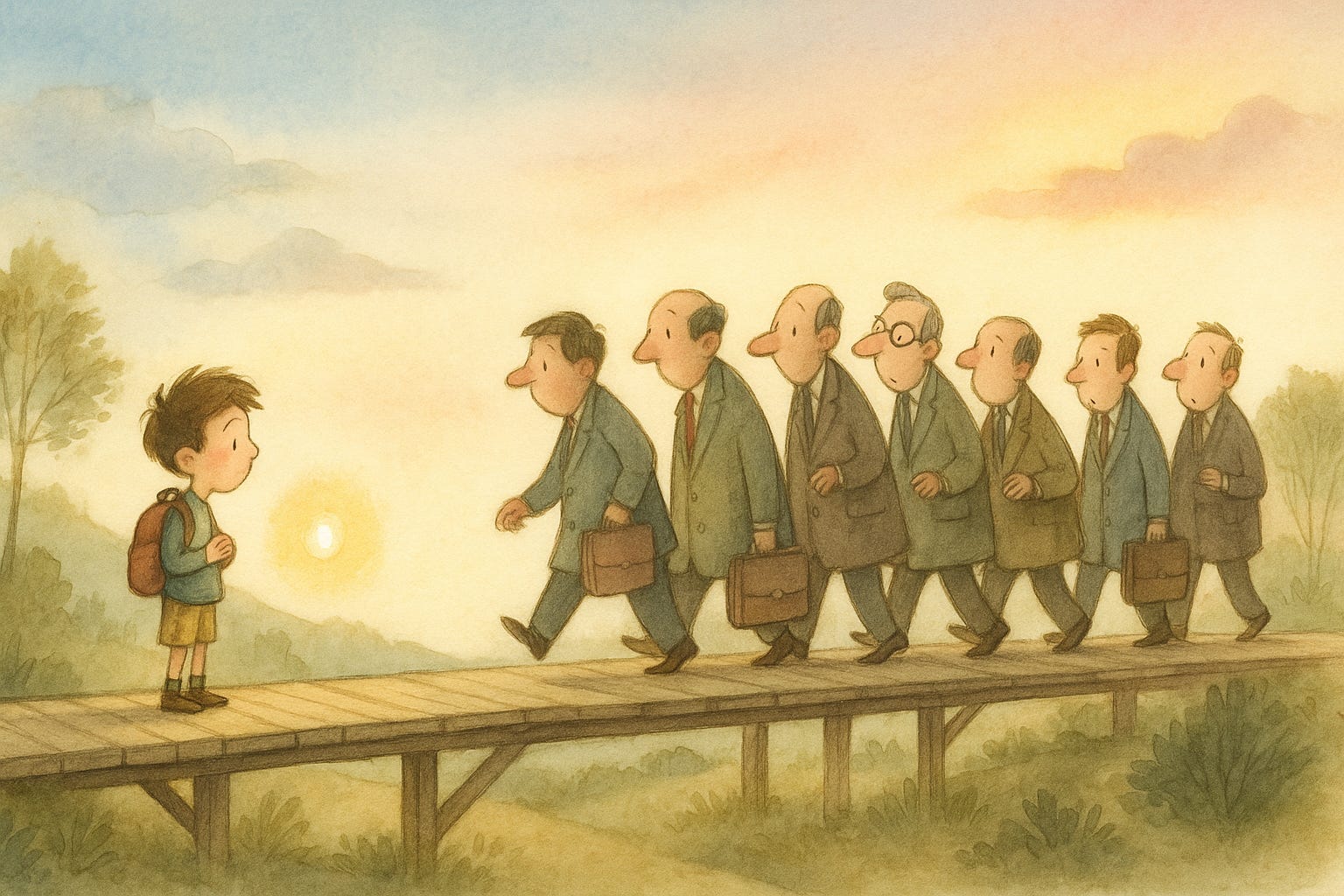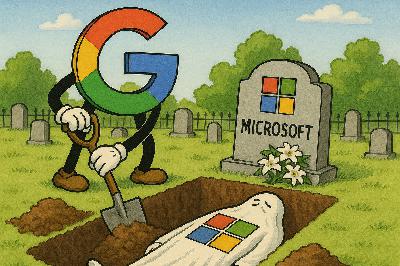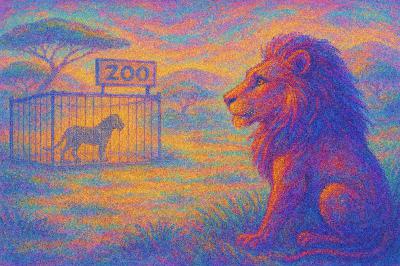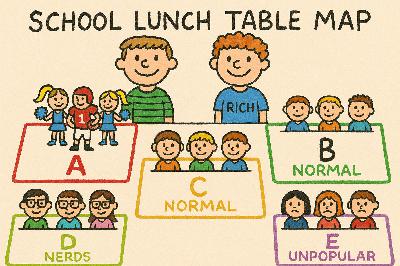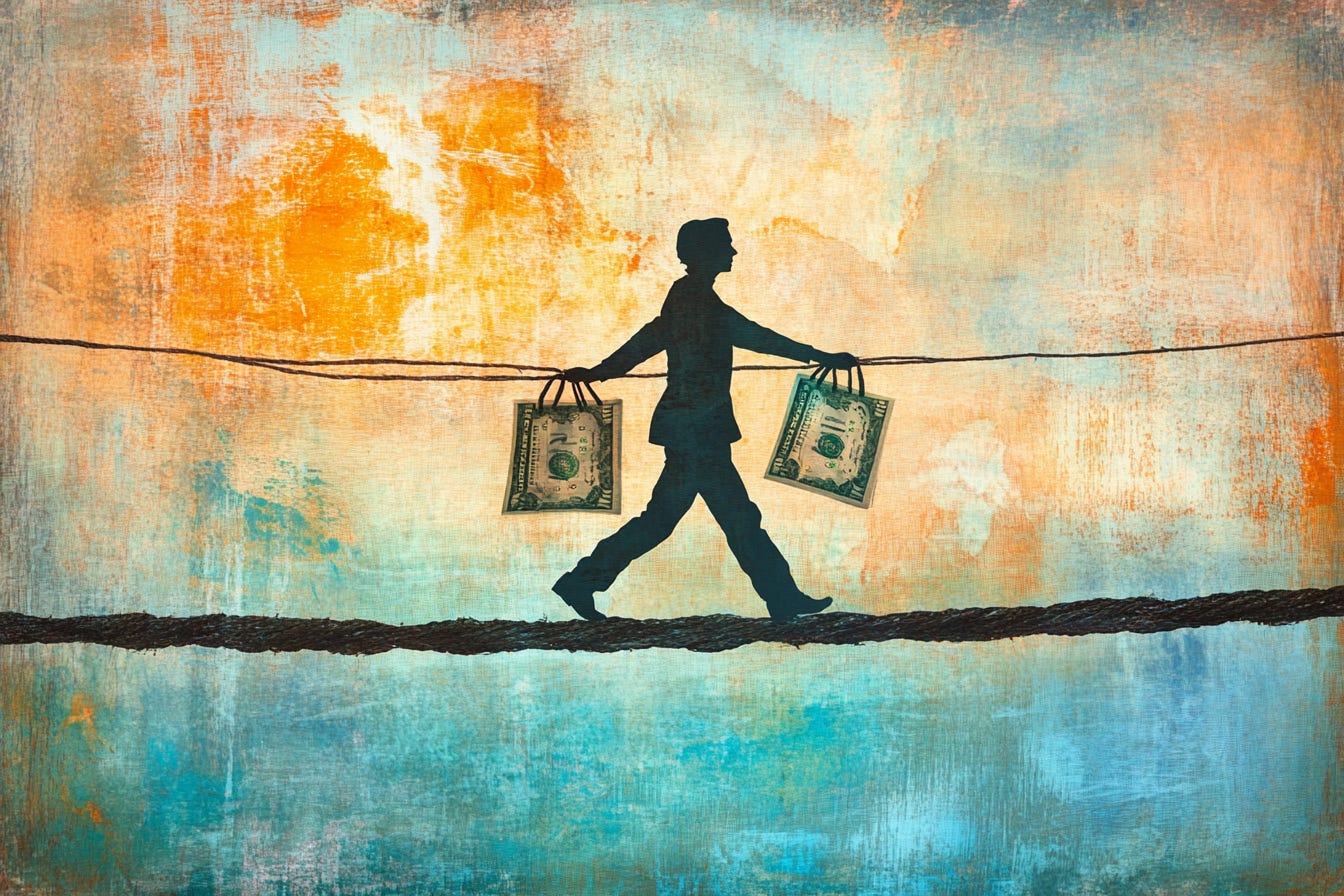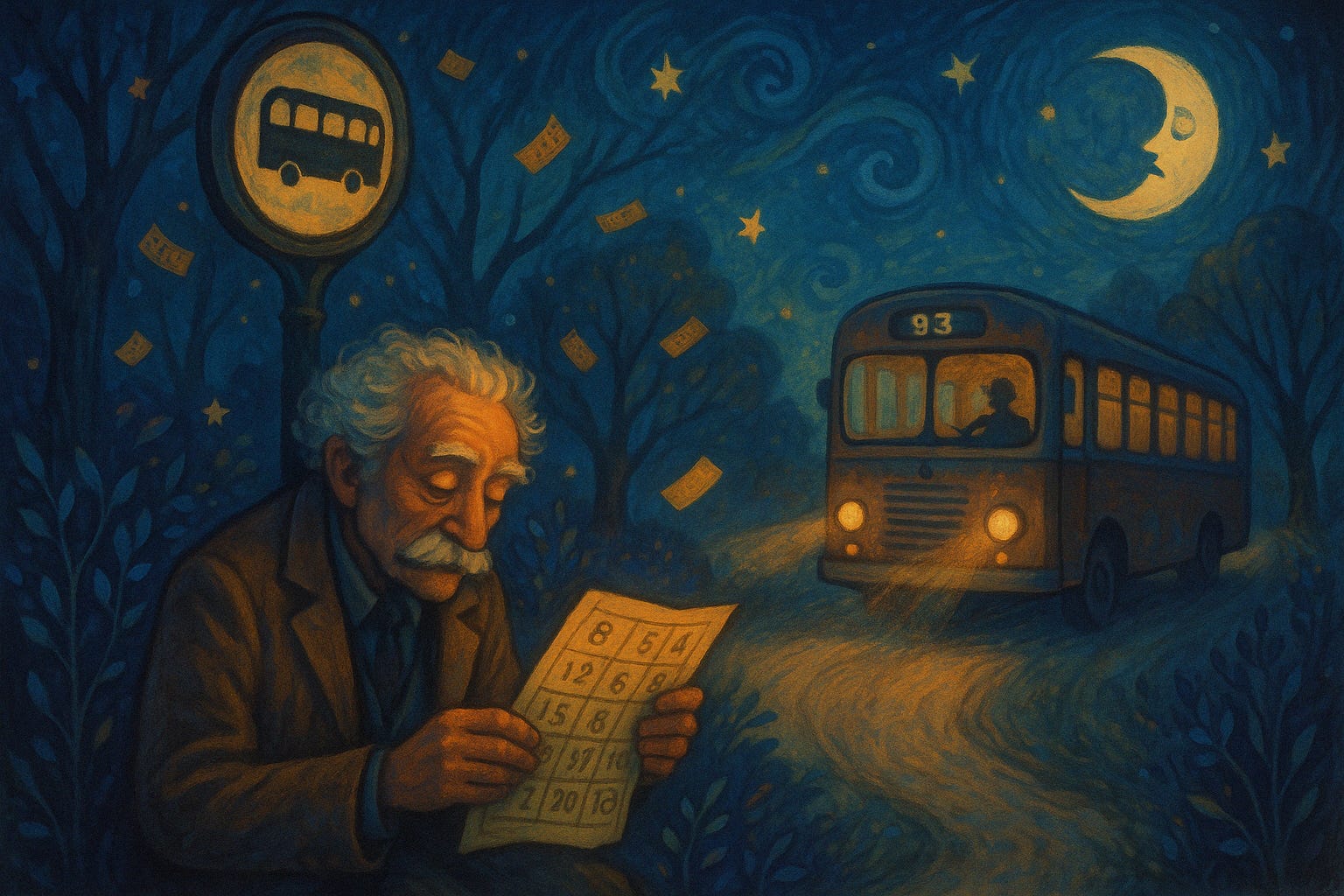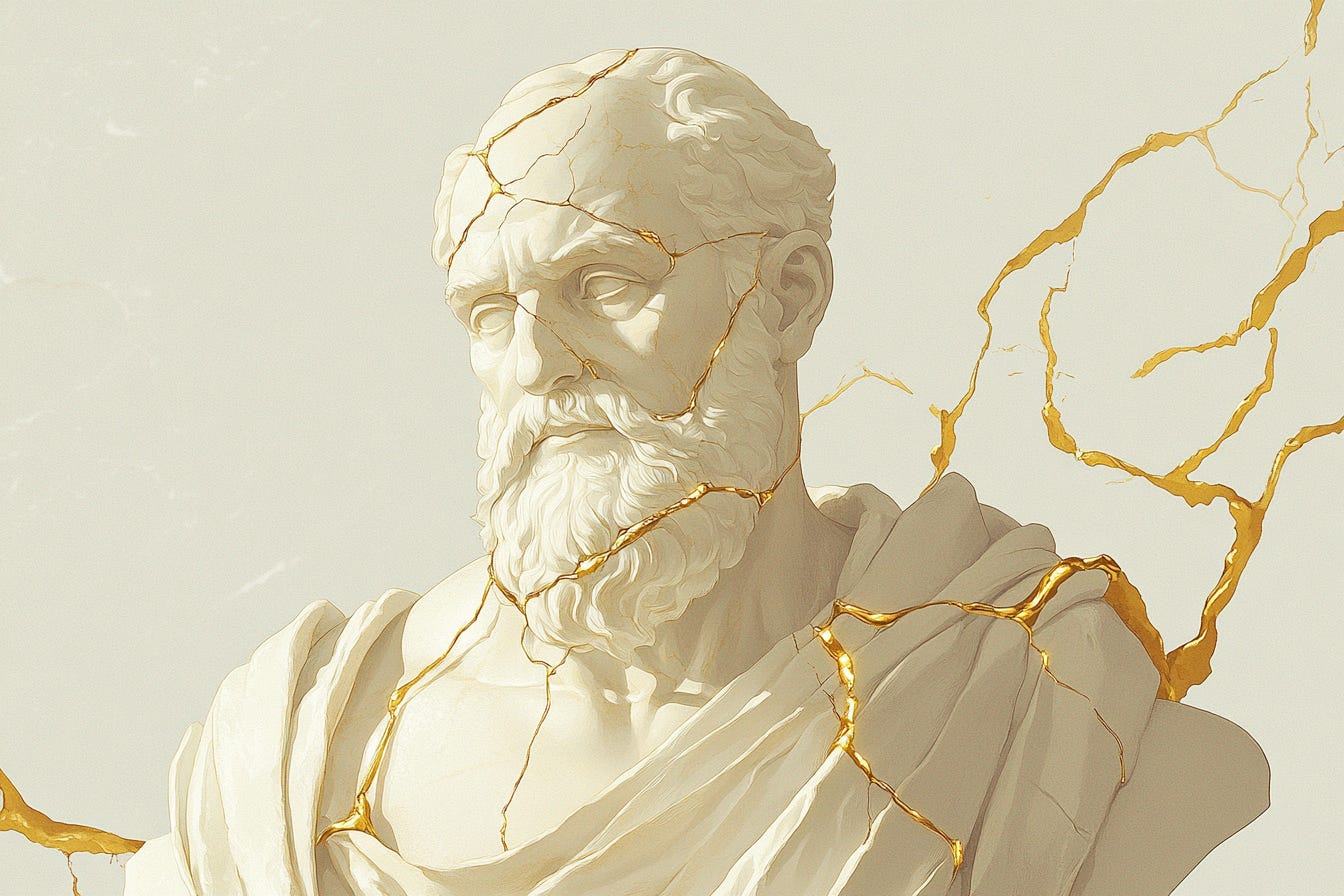La Riframmentazione // The Refragmentation
Description
Traduzione e lettura in italiano di Dario Ricci dall’essay originale di Paul Graham "The Refragmentation" [Gennaio 2016].
Uno dei vantaggi dell'invecchiare è osservare i cambiamenti che accadono nel corso della propria vita. Tra i cambiamenti cui ho assistito, il più importante è probabilmente la frammentazione della nostra società. La politica statunitense è molto più polarizzata di un tempo. Dal punto di vista culturale, non abbiamo mai avuto così poco in comune. I creativi si concentrano in poche città felici, abbandonando le altre. E la disuguaglianza economica tra ricchi e poveri non fa che aumentare. Vorrei proporre un'ipotesi: che tutte queste tendenze abbiano un'origine comune. E che ciò che le ha generate non sia una nuova forza che crea disuguaglianza, ma piuttosto l'erosione delle forze che ci avevano reso simili.
Le forze che ci avevano reso simili erano una combinazione unica di circostanze, un’anomalia che difficilmente si ripeterà - e che, anzi, preferiremmo non si ripetesse.
Si trattava in particolare di due forze: la guerra, in particolare la Seconda Guerra Mondiale, e l'ascesa delle grandi aziende.
La Seconda Guerra Mondiale ebbe conseguenze sia economiche che sociali.
Dal punto di vista economico, diminuirono le differenze di reddito. L'esercito americano, come tutte le forze armate moderne, era economicamente socialista: ognuno secondo le proprie capacità, ognuno secondo i propri bisogni. O quasi: nelle forze armate americane, come tipicamente accade nelle società socialiste, i membri di grado più elevato erano pagati di più.
L'appiattimento dei salari non si limitava ai membri delle forze armate, ma si applicava anche all’economia nel suo complesso. Tra il 1942 e il 1945, tutti i salari erano fissati dal National War Labor Board. La standardizzazione dei salari era così pervasiva che i suoi effetti continuarono per anni, anche dopo la fine della guerra.
Neanche gli imprenditori dovevano guadagnare più degli altri. Il presidente Roosevelt disse che non avrebbe permesso a nessuno di diventare un “milionario di guerra". Per questo, ogni aumento dei profitti di un'azienda rispetto ai livelli prebellici era tassato all'85%, mentre i profitti distribuiti alle persone fisiche venivano tassati al 93%.
Anche dal punto di vista sociale, la guerra appiattì le differenze. Quasi l’80% degli uomini nati nei primi anni Venti furono arruolati. Questo fece sì che oltre 16 milioni di persone delle più diverse estrazioni sociali fossero accomunate da uno stile di vita molto uniforme. E lavorare per un obiettivo comune, spesso sotto stress, li avvicinò ancora di più.
La Seconda Guerra Mondiale per gli Stati Uniti durò meno di 4 anni, ma i suoi effetti durarono molto più a lungo. È normale che durante le guerre i governi centrali assumano maggiori poteri, ma la Seconda Guerra Mondiale ne fu un caso estremo. Anche negli Stati Uniti, come in tutti gli altri Paesi alleati, il governo federale fu lento a rinunciare ai nuovi poteri acquisiti. Per certi aspetti, infatti, la guerra non finì nel 1945: semplicemente, l'Unione Sovietica divenne il nuovo nemico. Per quanto riguarda le tasse, il potere federale, la spesa per la difesa, gli obblighi di leva e il nazionalismo, i decenni successivi al 1945 assomigliarono più agli anni della guerra che al periodo di pace prebellico. Anche gli effetti sociali durarono a lungo: il ragazzo che prima di arruolarsi faceva l'agricoltore in West Virginia, una volta finita la guerra non tornava semplicemente alla sua fattoria. Lo aspettava una prospettiva diversa, una prospettiva civile che però assomigliava molto all'esercito.
Se dal punto di vista politico la storia americana del XX secolo è stata definita dalla guerra globale, la storia economica è stata invece definita dall'ascesa di un nuovo tipo di aziende. E anche questo fenomeno ha contribuito alla creazione di una forte coesione sociale ed economica.
Il XX secolo è stato il secolo delle grandi aziende nazionali: General Electric, General Foods,
General Motors. Gli sviluppi nel campo della finanza, delle comunicazioni, dei trasporti e
della produzione hanno portato alla formazione di un nuovo tipo di aziende che avevano come principale obiettivo la grande dimensione. Era un mondo a bassa risoluzione: poche grandi aziende dominavano ogni grande mercato, come pochi grandi mattoncini Duplo.
La fine del XIX e l'inizio del XX secolo fu un'epoca di consolidamento tra aziende, guidata soprattutto dal grande banchiere J. P. Morgan. Migliaia di aziende gestite dai loro fondatori si fusero fino a diventare decine di aziende giganti, gestite da manager professionisti: le economie di scala la facevano da padrone, e sembrava che questo fosse lo stato finale della struttura dell'economia. John D. Rockefeller disse nel 1880:
“Il consolidamento è qui per restare. L'individualismo è scomparso e non tornerà mai più.”
Vedendolo dalla prospettiva di oggi si sbagliava, ma per tutto il ‘900 sembrava proprio che le cose sarebbero andate così per sempre.
Il consolidamento tra aziende continuò per gran parte del XX secolo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, come scrive l’analista politico Michael Lind, "I principali settori dell'economia erano organizzati come cartelli sostenuti dal governo, o dominati da poche società oligopolistiche".
Ciò dava ai consumatori poche scelte, uguali per tutti. Quando ero adolescente, nella maggior parte dei casi c'erano solo 2 o 3 prodotti per ogni categoria. Tutte le aziende puntavano alla fascia media del mercato, il che faceva sì che le differenze tra un prodotto e l'altro fossero assai limitate.
Una delle espressioni più importanti di questo fenomeno era la TV. Tre erano le scelte possibili: NBC, CBS e ABC. Più la TV pubblica, che però guardavano solo intellettuali e comunisti. C'era una spinta all'omologazione che faceva sì che gli spettacoli offerti dalle tre reti fossero indistinguibili: se qualcuno tentava una programmazione anche solo lievemente più audace, gli inserzionisti facevano pressioni affinché si riallineasse.
Inoltre, visto che le televisioni erano costose, intere famiglie guardavano insieme gli stessi programmi, che quindi dovevano essere adatti a tutti.
Tutti ricevevano gli stessi contenuti nello stesso momento. Ogni sera, decine di milioni di famiglie si sedevano insieme davanti alla TV per guardare lo stesso programma, alla stessa ora. Quello che oggi accade una sera all'anno con il Super Bowl, un tempo accadeva ogni sera. Eravamo letteralmente sincronizzati.
Questa cultura televisiva dava una visione del mondo simile a quella che si può trovare in un libro per bambini: i contenuti erano semplici, e l’obiettivo era fare in modo che le persone si comportassero meglio. Ma questo, per gli adulti, rischiava di essere pericolosamente fuorviante.
Robert MacNeil, un famoso giornalista dell’epoca, racconta nella sua autobiografia di aver visto immagini raccapriccianti appena arrivate dal Vietnam e di aver pensato: "Non possiamo mostrarle alle famiglie mentre cenano".
So quanto quel pensiero unico fosse pervasivo perché ho provato a cercare alternative, ma era praticamente impossibile. All'età di 13 anni mi resi conto, più per evidenza interna che per riscontri esterni, che le idee che la TV ci propinava erano semplicistiche e fuorvianti, e smisi di guardarla. Ma il problema non era solo la TV. Sembrava che intorno a me non ci fosse nulla di autentico: i politici dicevano tutti le stesse cose; i marchi di consumo producevano prodotti quasi identici, ma con etichette diverse per indicare quanto fossero prestigiosi; le case erano semplici strutture in legno, ma rivestite per farle sembrare lussuose dimore coloniali; le auto avevano enormi carrozzerie di lamiera, che già dopo un paio d’anni dall’acquisto iniziavano a cadere a pezzi; le mele "red delicious" erano di un bel colore rosso, ma di delizioso non avevano nulla. Col senno di poi, faceva tutto schifo.
Andai alla ricerca di alternative, ma non trovai praticamente nulla. Internet non esisteva, l'unico posto dove cercare nuovi stimoli era la libreria del centro commerciale locale. Lì trovai una copia di The Atlantic. Mi piacerebbe dire che fu la porta di ingresso a un mondo alternativo, ma la verità è che lo trovai noioso e incomprensibile, come un bambino che assaggia il whisky per la prima volta e finge che gli piaccia. Nonostante ciò, conservai quella rivista come un cimelio, sono sicuro di averla ancora. Era la prova che esisteva, da qualche parte, un mondo che non era rosso e delizioso.
Le grandi aziende non ci rendevano simili solo come consumatori, ma anche come
lavoratori. Al loro interno agivano forze potenti, che spingevano le persone verso un unico modello estetico e comportamentale. L'IBM era particolarmente nota per questo, ma era solo un po' più estrema delle altre grandi aziende. E i modelli estetici e comportamentali variavano poco da un'azienda all'altra: in altre parole, in questo mondo ci si aspettava che tutti sembrassero più o meno uguali. E non solo chi lavorava in queste aziende, ma anche tutti coloro che aspiravano a lavorarci. Il che, a metà del XX secolo, significava la maggior parte delle persone che non ne facevano già parte. In quegli anni, la classe operaia faceva di tutto per sembrare borghese. Lo si può vedere nelle vecchie foto: pochi adulti aspiravano a sembrare pericolosi nel 1950.
Oltre che dal punto di vista culturale, l’ascesa delle grandi aziende nazionali limitò l’individualità anche dal punto di vista economico, mediante una poco meritocratica compressione delle retribuzioni verso la media.
Questo avvenne innanzitutto grazie all'operato dei grandi sindacati naz